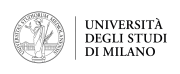Ludwig Wittgenstein
Libro blu
Traduzione di Luca Bernardi
Questa traduzione è stata condotta su una versione normalizzata del dattiloscritto originale inglese n. 309 (Ts-309, detto Blue Book) del Nachlass di Wittgenstein generata grazie allo strumento di presentazione dinamica interattiva (Interactive Dynamic Presentation)[N] messo a disposizione dai Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB). La traduzione è stata revisionata da Michele Lavazza. Il testo originale è nel pubblico dominio nel suo paese di origine e in tutti i paesi dove i diritti di proprietà intellettuale scadono 70 anni o meno dopo la morte dell’autore. Questa traduzione è stata realizzata dal Ludwig Wittgenstein Project grazie al sostegno dell’Università degli Studi di Milano, erogato nell’ambito del bando 2021-2022 per il finanziamento delle attività culturali e sociali a cui il Ludwig Wittgenstein Project ha partecipato in collaborazione con l’Associazione Culturale La Taiga. È pubblicata secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0.
Ludwig Wittgenstein
Libro blu
|(Ts-309,1) Che cos’è il significato di una parola?
Affrontiamo la domanda chiedendoci, prima, che cos’è la spiegazione del significato di una parola; che aspetto ha la spiegazione di una parola?
Quest’interrogativo ci aiuta in maniera analoga a come la domanda «come misuriamo una lunghezza?» ci aiuta a comprendere il problema «che cos’è la lunghezza?»
Le domande «che cos’è la lunghezza?», «che cos’è il significato?», «che cos’è il numero uno?» ecc. ci procurano un crampo mentale. Sentiamo di non poter indicare nulla a mo’ di risposta, eppure abbiamo l’impressione di dover indicare qualcosa. (Ci troviamo a fronteggiare una delle grandi fonti di confusione filosofica: cerchiamo di trovare una sostanza per un sostantivo).
Chiedersi prima «che cos’è una spiegazione di significato?» ha due vantaggi. In un certo senso rende piuttosto concreta la domanda «che cos’è il significato?». Certamente, infatti, per comprendere il significato di «significato» bisogna comprendere anche il significato di «spiegazione di significato». Approssimando: «Chiediamoci che cos’è è la spiegazione di significato, perché qualunque cosa essa spieghi sarà il significato». Studiare la grammatica dell’espressione «spiegazione di significato» ti insegnerà qualcosa sulla grammatica della parola «significato» e ti curerà dalla tentazione di guardarti attorno alla ricerca di qualcosa che potresti chiamare il «significato».
Ciò che generalmente si chiama «spiegazione del significato |(Ts-309,2) di una parola» può, molto grossolanamente, essere suddiviso in definizioni verbali e ostensive. Si vedrà in seguito in che senso questa divisione è soltanto approssimativa e provvisoria (che lo sia è di grande importanza). La definizione verbale, portandoci da un’espressione verbale a un’altra, in un certo senso non ci fa fare progressi. Sembra invece che la definizione ostensiva ci faccia compiere un passo ben più importante verso l’apprendimento del significato.
Una difficoltà che ci colpisce è che per molte parole del nostro linguaggio non paiono esserci definizioni ostensive; per esempio, per parole come «uno», «numero», «non» ecc.
Domanda: la definizione ostensiva stessa deve essere compresa? – La definizione ostensiva non può essere fraintesa?
Se la definizione spiega il significato di una parola, certamente non può essere necessario aver già sentito tale parola. È compito della definizione ostensiva darle un significato. Spieghiamo la parola «tove» indicando una matita e dicendo «questo è tove». (Invece di «questo è tove» avrei potuto dire «questo è chiamato “tove”». Lo sottolineo per rimuovere, una volta per tutte, l’idea che le parole della definizione ostensiva predichino qualcosa del definito; la confusione tra la frase «questo è rosso», che attribuisce il colore rosso a qualcosa, e la definizione ostensiva «questo è chiamato “rosso”».) Ora, la definizione ostensiva «questo è tove» può dare adito a tutta una serie di interpretazioni. Fornirò alcune di queste interpretazioni e userò parole italiane dall’impiego ben stabilito. La definizione dunque potrebbe venir interpretata come se significasse: – |(Ts-309,3)
«Questo è una matita»,
«Questo è rotondo»,
«Questo è legno»,
«Questo è uno»,
«Questo è duro», ecc. ecc.
A tale argomento si potrebbe obiettare che tutte queste interpretazioni presuppongono un altro linguaggio verbale. E l’obiezione è significativa, se per «interpretazione» intendiamo unicamente «traduzione in un linguaggio verbale». – Darò ora qualche accenno che forse contribuirà a renderlo più chiaro. Chiediamoci quale è il nostro criterio quando diciamo che qualcuno ha interpretato la definizione ostensiva in un certo modo. Supponi che io fornisca a un inglese la definizione ostensiva «questo è ciò che i tedeschi chiamano “Buch”». Allora, nella grande maggioranza dei casi, quanto meno, all’inglese verrà in mente la parola inglese «book». Possiamo dire che ha interpretato «Buch» come se volesse dire «book». Il caso sarà diverso se, per esempio, indicandogli un oggetto che non ha mai visto prima, gli diciamo: «Questo è un banjo». Magari gli verrà in mente la parola «chitarra», magari non gli sovverrà alcuna parola bensì l’immagine di uno strumento simile, oppure proprio nulla. Supponiamo che io gli dia il comando: «Prendi un banjo tra questi oggetti». Se lui prende ciò che noi chiamiamo un «banjo», noi potremmo dire: «Ha dato alla parola “banjo” l’interpretazione corretta»; se prende qualche altro strumento: – «Ha interpretato “banjo” come se significasse “strumento a corde”».
Diciamo «ha dato alla parola “banjo” questa o quella interpretazione» |(Ts-309,4) e siamo propensi a presupporre un preciso atto d’interpretazione oltre all’atto di scegliere.
Il nostro problema è analogo al seguente: – se do a qualcuno l’ordine “portami un fiore rosso da quel prato,” lui come farà a sapere che tipo di fiore portarmi, visto che gli ho dato solo una parola?
La prima risposta che si potrebbe suggerire è che costui è andato a cercare un fiore rosso portandosi nella mente un’immagine rossa e confrontandola con i fiori per vedere quali avevano il colore dell’immagine. Ora, un tale modo di cercare esiste e non è affatto essenziale che l’immagine impiegata debba essere un’immagine mentale. In effetti, il processo potrebbe essere questo: – porto con me una tabella che coordina nomi e riquadri colorati. Quando sento l’ordine «portami ecc.», sposto il dito lungo una riga della tabella dalla parola «rosso» fino un certo riquadro, poi vado a cercare un fiore che ha lo stesso colore del riquadro. Questo però non è l’unico modo di cercare e non è nemmeno quello abituale. Andiamo, ci guardiamo attorno, ci avviciniamo a un fiore e lo cogliamo, senza confrontarlo con nulla. Per vedere che il processo di eseguire il comando può essere di questo tipo, considera il comando «immagina una chiazza rossa». In questo caso non sei tentato di pensare che prima di obbedire devi aver immaginato una chiazza rossa che ti sia servita da modello per la chiazza rossa che ti era stato ordinato d’immaginare.
Adesso potresti chiedere: «Interpretiamo le parole prima di obbedire al comando?». E in certi casi scoprirai di fare, prima di obbedire, qualcosa che potrebbe essere chiamato interpretare, in altri casi no. |(Ts-309,5)
Sembra che, collegati con il funzionamento del linguaggio, ci siano certi specifici processi mentali; processi senza cui il linguaggio non può funzionare. Intendo i processi di comprendere e intendere. I segni del nostro linguaggio paiono morti senza questi processi mentali; e potrebbe sembrare che l’unica funzione dei segni sia indurre tali processi, e che siano questi ciò a cui davvero dovremmo interessarci. Quindi, se ti chiedono qual è la relazione tra un nome e la cosa che nomina, tu sarai propenso a rispondere che si tratta di una relazione psicologica e magari nel dirlo penserai in particolare al meccanismo dell’associazione. – Siamo tentati di pensare che l’azione del linguaggio consista di due parti; una parte inorganica, il maneggiare i segni, e una parte organica, che potremmo chiamare il comprendere questi segni, l’intenderli, l’interpretarli, il pensare. Queste ultime attività paiono aver luogo in un tipo bizzarro di mezzo, la mente; e il meccanismo della mente, la cui natura, sembra, non capiamo del tutto, può produrre effetti impossibili per qualunque meccanismo materiale. Dunque, per esempio, un pensiero (che è un tale processo mentale) può essere in accordo o in disaccordo con la realtà: sono in grado di pensare a un uomo che non è presente; sono in grado di immaginarlo, «intenderlo», in un commento che faccio su di lui, anche se è lontano migliaia di chilometri, o morto. «Che meccanismo bizzarro dev’essere», si potrebbe dire, «il meccanismo del desiderare, se posso desiderare ciò che non accadrà mai».
C’è un modo di evitare almeno parzialmente l’aspetto occulto del processo del pensare e consiste nel rimpiazzare, in tali processi, ogni coinvolgimento dell’immaginazione con l’osservazione di oggetti |(Ts-309,6) reali. Quindi può sembrare essenziale che, almeno in certi casi, quando sento la parola «rosso» e la comprendo, un’immagine rossa dovrebbe apparirmi all’occhio della mente. Ma perché non dovrei sostituire il fatto di immaginare una superficie rossa con il fatto di vedere un pezzo di carta rossa? L’immagine visiva non farà che guadagnarne in vividezza. Puoi facilmente immaginare un uomo che si porta in tasca un foglio su cui i nomi dei colori sono coordinati a chiazze colorate. Puoi dire che il fatto di portarsi sempre dietro tale tabella di campioni sarebbe un fastidio e che noi invece ci serviamo sempre del meccanismo dell’associazione. Ma ciò è irrilevante; e in molti casi non è neppure vero. Se, per esempio, ti ordinassero ti dipingere una particolare tinta di blu chiamata «blu di Prussia», potresti avere bisogno di una tabella che dall’espressione «blu di Prussia» ti porti a un campione del colore, che fungerebbe da copia.
Per i nostri scopi, potremmo benissimo rimpiazzare qualunque processo consistente nell’immaginare con un processo consistente nell’osservare un oggetto, oppure nel dipingerlo, disegnarlo o modellarlo; e ogni processo di parlare da soli con il processo di parlare ad alta voce o di scrivere.
Frege ha ridicolizzato la concezione formalista della matematica dicendo che i formalisti confondevano la cosa triviale, il segno, con quella importante, il significato. Certamente, si vorrebbe dire, la matematica non si occupa di trattini su un foglio di carta. L’idea di Frege potrebbe essere espressa così: se fossero soltanto complessi di trattini, le proposizioni della matematica sarebbero morte e del tutto prive di interesse e invece, ovviamente, in qualche modo sono vive. E lo stesso, ovviamente, si potrebbe dire di qualsiasi proposizione: senza un senso, o senza il pensiero, una proposizione sarebbe una cosa morta e |(Ts-309,7) assolutamente triviale. Inoltre sembra chiaro che nessun’aggiunta di segni inorganici può rendere viva la proposizione. E la conclusione a cui tutto questo ci fa porta è che ciò che va aggiunto ai segni morti per rendere viva una proposizione è qualcosa d’immateriale con proprietà diverse da qualsiasi mero segno.
Ma se dovessimo nominare qualcosa che è la vita del segno, dovremmo dire che è il suo uso.
Se il significato del segno (detto rozzamente, ciò che del segno è importante) è un’immagine costruita nelle nostre menti quando vediamo o sentiamo pronunciare il segno, allora perché non adottare innanzitutto il metodo, descritto sopra, di rimpiazzare questa immagine mentale con il fatto di vedere un qualche oggetto esterno, per esempio un’immagine dipinta o modellata? Ma allora perché il segno scritto a cui si somma quest’immagine dipinta dovrebbe essere vivo, se il segno scritto da solo era morto? – Infatti, non appena pensi di rimpiazzare l’immagine mentale con, poniamo, un’immagine dipinta, e non appena l’immagine perde così il suo carattere occulto, essa cessa completamente di dare l’impressione di infondere in qualche modo la vita nella frase. (In realtà per i tuoi scopi avevi bisogno proprio del carattere occulto del processo mentale.)
L’errore che rischiamo di commettere può essere espresso così: cerchiamo l’uso di un segno, ma lo cerchiamo come se fosse un oggetto che co-esiste con il segno. (Una delle ragioni di quest’errore è, di nuovo, il fatto che cerchiamo «una cosa che corrisponda a un sostantivo».)
Il segno (la frase) ottiene la propria significazione dal sistema di segni, dal linguaggio cui appartiene. Grossolanamente: comprendere una frase significa comprendere un linguaggio. |(Ts-309,8)
Come parte del sistema del linguaggio, si potrebbe dire «la frase ha vita». Si è però tentati d’immaginare ciò che dà vita alla frase come qualcosa che abita una sfera occulta e che accompagna la frase. Ma qualunque cosa la accompagni sarebbe per noi soltanto un altro segno.
A un primo sguardo, pare che a dare al pensiero il suo carattere peculiare sia il fatto che esso sia una sequenza di stati mentali e sembra che ciò che del pensare è bizzarro e difficile da comprendere consista nei processi in atto nel mezzo della mente, processi che sono possibili soltanto in questo mezzo. Qui il paragone che ci si impone è quello tra il mezzo mentale e il protoplasma di una cellula, per esempio di un’ameba. Osserviamo certe azioni di un’ameba, il suo assumere cibo allungando le braccia, il suo dividersi in cellule simili, ognuna delle quali cresce e si comporta come la prima. Diciamo: «Che natura bizzarra deve avere il protoplasma della cellula per comportarsi così», e magari affermiamo che nessun meccanismo fisico potrebbe agire in questa maniera e che il meccanismo dell’ameba dev’essere unico nel suo genere. Analogamente, siamo tentati di dire: «Il meccanismo della mente dev’essere di un tipo molto particolare per essere in grado di fare ciò che fa la mente». Qui però compiamo due errori. Perché ciò che a noi è parso bizzarro del pensiero e del pensare non era il fatto che avesse effetti curiosi che non eravamo in grado di spiegare (causalmente). Il nostro problema, in altre parole, non era scientifico; bensì un pasticcio dava l’impressione di essere un problema.
Ipotizziamo che si tenti di costruire un modello della mente come risultato di indagini psicologiche, un modello che, diremmo, |(Ts-309,9) spieghi l’azione della mente. Questo modello farebbe parte di una teoria psicologica nel modo in cui un modello meccanico dell’etere può rientrare in una teoria dell’elettricità. (Tale modello, peraltro, è sempre parte del simbolismo di una teoria. Il suo vantaggio è forse che lo si coglie a un primo sguardo e lo si tiene a mente senza sforzo. È stato detto che un modello, in un certo senso, riveste la teoria pura; che la nuda teoria sono frasi o equazioni. Ciò va esaminato più attentamente in seguito.)
Possiamo scoprire che, per spiegare le attività mentali osservate, tale modello della mente dovrebbe essere molto complicato e intricato; e per questa ragione potremmo definire la mente un mezzo bizzarro. Quest’aspetto della mente però non ci interessa. I problemi che esso può porre sono psicologici e il metodo per risolverli è quello della scienza naturale.
Dunque, se non è alle connessioni causali che siamo interessati, le attività della mente giacciono aperte davanti ai nostri occhi. E quando ci preoccupiamo della natura del pensare, la perplessità che erroneamente interpretiamo come riguardante la natura del mezzo è una perplessità causata dall’uso mistificante del nostro linguaggio. Questo tipo di errore ricorre continuamente in filosofia, per esempio la natura del tempo ci lascia perplessi; quando il tempo ci pare una cosa bizzarra. Siamo fortemente tentati di credere che qui ci sia qualcosa di nascosto, qualcosa che possiamo vedere da fuori ma dentro cui non riusciamo a guardare. Eppure, non è affatto così. Ciò che vogliamo conoscere non sono nuovi fatti riguardo al tempo. Tutti i fatti che ci interessano giacciono aperti davanti a noi. È invece l’uso del sostantivo «tempo» a trarci in errore. Se investighiamo |(Ts-309,10) la grammatica di questa parola, il fatto che l’uomo ha concepito una divinità del tempo ci pare tanto sbalorditivo quanto l’eventualità che possa concepire una divinità della negazione o della disgiunzione.
È dunque fuorviante parlare del pensare come di un’«attività mentale». Possiamo dire che pensare è essenzialmente l’attività di operare con segni. Quest’attività è compiuta dalla mano, quando pensiamo scrivendo; dalla bocca e dalla laringe, quando pensiamo parlando; mentre se pensiamo immaginando segni o figure non posso fornirvi alcun agente pensante. Se allora in tali casi tu dicessi che la mente pensa, io ti farei presente che stai impiegando una metafora, che qui la mente è un agente in un senso diverso dal senso in cui la mano può essere detta l’agente nella scrittura.
Se di nuovo parliamo della località in cui ha luogo il pensare facciamo bene a dire che tale località è il foglio su cui scriviamo; oppure la bocca che parla. E se parliamo della testa o del cervello in quanto località del pensiero, stiamo usando l’espressione «località del pensare» in un senso diverso. Prendiamo in esame le ragioni per cui la testa è considerata la sede del pensiero. Non è nostra intenzione criticare tale forma d’espressione, oppure mostrare che non è appropriata. Ciò che dobbiamo fare è: comprendere il suo funzionamento, la sua grammatica, per esempio vedere che relazione ha questa grammatica con quella dell’espressione «pensiamo con la bocca», oppure «pensiamo con la penna sul pezzo di carta».
Forse la ragione principale per cui siamo tanto fortemente propensi a parlare della testa come della località dei nostri pensieri è la seguente: – l’esistenza delle parole «pensare» e «pensiero» accanto alle |(Ts-309,11) parole che denotano attività (corporee) quali scrivere, parlare, ecc. ci porta a cercare un’attività, diversa da queste ma a loro analoga, che corrisponde alla parola «pensare». Quando parole nel nostro linguaggio ordinario hanno prima facie grammatiche analoghe, siamo portati a interpretarle in analogia; ossia cerchiamo di mantenere l’analogia fino in fondo. – Diciamo: «Il pensiero non è lo stesso della frase; perché una frase inglese e una frase francese, pur essendo completamente diverse, possono esprimere lo stesso pensiero». Poi, dato che le frasi sono da qualche parte, cerchiamo un luogo per il pensiero. (È come se cercassimo il luogo del re di cui si occupano le regole degli scacchi, invece dei luoghi dei vari pezzi di legno, ecc., i re delle varie scacchiere.) – Diciamo: «Certamente il pensiero è qualcosa; non è vero che non è nulla»; e a questo si può rispondere soltanto che la parola «pensiero» ha il suo uso, che è di tipo completamente diverso rispetto all’uso della parola «frase».
Ciò significa che è insensato parlare della località in cui si svolge il pensiero? Certamente no. Quest’espressione ha senso, se le diamo senso. Se allora diciamo «il pensiero ha luogo nella testa», qual è il senso di quest’espressione compresa sobriamente? Immagino sia che certi processi fisiologici corrispondono ai nostri pensieri in modo tale che, se conosciamo la corrispondenza, osservando tali processi possiamo trovare i pensieri. Ma in che senso si può dire che i processi fisiologici corrispondono ai pensieri e in che senso si può dire che ricaviamo i pensieri dall’osservazione del cervello?
Suppongo che immaginiamo che la corrispondenza sia stata verificata |(Ts-309,12) sperimentalmente. Immaginiamo rozzamente un simile esperimento. Consiste nel guardare il cervello mentre il soggetto pensa. Ora tu potresti pensare che la ragione per cui la mia spiegazione fallirà è che naturalmente lo sperimentatore ricava i pensieri del soggetto solo indirettamente, ossia facendoseli dire, il soggetto esprimendoli in un modo o nell’altro. Ma io rimuoverò tale difficoltà presumendo che il soggetto sia allo stesso tempo lo sperimentatore, che scruta il proprio cervello ad esempio tramite uno specchio. (La rozzezza della descrizione non riduce affatto la forza dell’argomento.)
Poi ti chiedo: il soggetto-sperimentatore osserva una cosa o due cose? (Non dire che sta osservando una cosa sia dall’interno sia dall’esterno; perché ciò non rimuove la difficoltà. Parleremo in seguito d’interno ed esterno.) Il soggetto-sperimentatore sta osservando una correlazione di due fenomeni. Uno di questi, magari, lui lo chiama il pensiero. Potrebbe consistere in una sequenza d’immagini, sensazioni organiche, oppure invece della sequenza delle varie esperienze visive, tattili e muscolari che ha avuto scrivendo o pronunciando una frase. – L’altra esperienza consiste nel vedere il suo cervello all’opera. Entrambi questi fenomeni potrebbero correttamente essere chiamati «espressioni di pensiero»; e la domanda «dov’è il pensiero stesso?», per evitare confusioni, andrebbe rifiutata in quanto insensata. Tuttavia, se usiamo lo stesso l’espressione «il pensiero ha luogo nella nostra testa», le abbiamo dato il significato che ha descrivendo l’esperienza che giustificherebbe l’ipotesi «il pensiero ha luogo nella nostra testa» per mezzo della descrizione di ciò che chiamiamo l’esperienza di osservare |(Ts-309,13) il pensiero all’interno del cervello.
Dimentichiamo facilmente che la parola «località» è utilizzata in molti sensi diversi e che ci sono molti tipi diversi di affermazioni inerenti a una cosa che in un caso particolare, in accordo con l’uso generale, chiameremmo «specificazioni della località della cosa». Quindi si è detto dello spazio visivo che il suo luogo è nella nostra testa; e penso che in noi la tentazione di dirlo sia scaturita, almeno in parte, da un malinteso grammaticale.
Posso dire: «nel mio campo visivo vedo l’immagine dell’albero a destra dell’immagine della torre», oppure «vedo l’immagine dell’albero al centro del campo visivo». E ora siamo propensi a chiedere: «E dove vedi il campo visivo?». Se il «dove» è inteso a chiedere una località nel senso in cui abbiamo specificato la località dell’immagine dell’albero, allora ti farei presente che non hai ancora dato un senso alla domanda; che cioè ti sei mosso in base a un’analogia grammaticale senza averla elaborata nel dettaglio.
Nel dire che l’idea secondo cui il nostro campo visivo è localizzato nel cervello è scaturita da un fraintendimento grammaticale, non intendevo affermare che non si potrebbe dare senso a una tale specificazione di località. Per esempio, si potrebbe facilmente immaginare un’esperienza che descriveremmo con una tale affermazione. Immagina di guardare un gruppo di oggetti in questa stanza; mentre sei intento a osservarli, qualcuno ti inserisce una sonda nel cervello e scopre che, se la punta della sonda arriva in un punto particolare del cervello, una piccola porzione specifica del tuo campo visivo risulta cancellata. Così potremmo coordinare punti del cervello con punti |(Ts-309,14) dell’immagine visiva e ciò potrebbe farci dire che il campo visivo è situato nel tale o nel talaltro luogo del cervello. E se noi allora chiedessimo «dove vedi l’immagine di questo libro?» la risposta potrebbe essere (come sopra) «a destra di quella matita», oppure «nella zona sinistra del mio campo visivo», oppure ancora: «otto centimetri dietro il mio occhio sinistro».
E se invece qualcuno dicesse: «Ti assicuro che sento l’immagine visiva cinque centimetri dietro il ponte del naso»? Noi che cosa dovremmo rispondergli? Bisognerebbe dirgli che non sta dicendo la verità, o che una tale sensazione non può darsi? E se lui poi ci chiedesse: «Conosci tutte le sensazioni che si danno? Come fai a sapere che tale sensazione non si dà?»?
E se il rabdomante ci dice che, quando stringe il bastone, sente che l’acqua è un metro e mezzo sottoterra? Oppure che sente che un misto di rame e oro si trova un metro e mezzo sottoterra? Supponi che ai nostri dubbi lui risponda: «Tu sai stimare una lunghezza a occhio. Perché io non potrei avere un altro modo di stimarla?»
Se capiamo l’idea di una tale stima, faremo chiarezza sulla natura dei nostri dubbi riguardo alle affermazioni del rabdomante, e riguardo a quelle dell’uomo che diceva di sentire l’immagine visiva dietro il ponte del naso.
C’è l’affermazione: «Questa matita è lunga dieci centimetri» e c’è l’affermazione: «Ho l’impressione che questa matita sia lunga dieci centimetri» e dobbiamo fare chiarezza sulla relazione tra la grammatica della prima e la grammatica della seconda. All’affermazione: «Sento nella mano che l’acqua è un metro sottoterra» |(Ts-309,15) bisognerebbe rispondere: «Non so cosa significa». Il rabdomante però direbbe: «Certo che sai cosa significa. Sai cosa significa “un metro sottoterra” e sai cosa significa “sento”», Ma io gli risponderei: «So cosa significa una parola in certi contesti. Quindi comprendo l’espressione “un metro sottoterra”, per esempio, nelle connessioni “la misurazione ha mostrato che l’acqua scorre un metro sottoterra”, “se scaviamo fino a un metro di profondità, troviamo l’acqua”. “a occhio, la profondità dell’acqua è di un metro”. Ma l’impiego dell’espressione “una sensazione nelle mani del fatto che l’acqua si trova un metro sottoterra” non mi è ancora stato spiegato».
Potremmo chiedere al rabdomante: «Come hai imparato il significato della locuzione “un metro?”». Supponiamo che gli abbiano mostrato tali lunghezze, che poi lui le abbia misurate, e simili. Ti hanno anche insegnato a parlare della sensazione che l’acqua si trovi un metro sottoterra, una sensazione, per esempio, nelle mani? Altrimenti, che cosa ti ha fatto connettere la locuzione «un metro» con una sensazione nelle mani? Immaginiamo di aver già stimato delle lunghezze a occhio, ma mai a spanne. Come potremmo stimare una lunghezza in centimetri misurandola a spanne? Cioè, come potremmo interpretare in centimetri l’esperienza di misurare a spanne? La domanda è quale connessione c’è, per esempio, tra una sensazione tattile e l’esperienza di misurare un oggetto con una sbarra da un metro? Tale connessione ci mostrerà che cosa significa «sentire che qualcosa è lungo quindici centimetri». Immaginiamo che il rabdomante dica «non ho mai imparato a correlare la profondità dell’acqua sottoterra con delle sensazioni nelle mani, ma quando avverto una certa sensazione di tensione nelle mani, mi viene in |(Ts-309,16) mente la locuzione “un metro”». Noi risponderemmo: «Questa è un’ottima spiegazione di ciò che intendi per “sentire che la profondità è di un metro” e l’affermazione secondo cui tu lo senti non avrà né più né meno significato di quanto gliene ha dato la tua spiegazione. E se l’esperienza ti mostra che l’effettiva profondità dell’acqua combacia sempre con la locuzione “n metri” che ti sorge nella mente, allora la tua esperienza sarà di grande utilità per determinare la profondità dell’acqua». – Vedi però che il significato delle parole «sento che la profondità dell’acqua è di n metri» andava spiegato; non era noto quando era noto il significato della locuzione «n metri» nel senso ordinario (ossia nei contesti ordinari). – Non diciamo che l’uomo che sostiene di sentire l’immagine visiva cinque centimetri dietro il ponte del naso mente o fa affermazioni prive di senso. Diciamo però che non comprendiamo il significato della sua locuzione. Tale espressione combina parole ben note, ma le combina in un modo che non riusciamo ancora a comprendere. La grammatica di questa frase deve ancora venirci spiegata.
L’importanza di analizzare la risposta del rabdomante sta nel fatto che spesso pensiamo di aver dato un significato a un’affermazione P semplicemente asserendo «sento (o credo) che si dia il caso che P». (Più avanti parleremo del professor Hardy, secondo cui il teorema di Goldbach è una proposizione perché lui può credere che sia vero.) Abbiamo già detto che limitandoci a spiegare il significato della locuzione «un metro» nella maniera usuale, non abbiamo ancora spiegato il senso dell’espressione «sentire che l’acqua è a un metro ecc.». Se però il rabdomante avesse detto di aver imparato a stimare la profondità |(Ts-309,17) dell’acqua, poniamo, mettendosi a scavare alla ricerca d’acqua ogni volta che avvertiva una sensazione particolare e così correlando tali sensazioni con misurazioni della profondità, noi non avremmo avuto simili difficoltà. Ora dobbiamo esaminare la relazione tra il processo di imparare a stimare e l’atto di stimare. L’importanza di questa disamina risiede nel fatto che si applica alla relazione tra l’apprendimento del significato di una parola e l’impiego della parola. O, più in generale, che mostra le differenti relazioni possibili tra una regola data e le sue applicazioni.
Consideriamo ora il processo di stimare una lunghezza a occhio: è estremamente importante che tu ti renda conto che ci sono moltissimi processi diversi che noi chiamiamo «stimare a occhio».
Consideriamo questi casi: –
1. Qualcuno chiede: «Come hai stimato l’altezza di questo edificio?» Rispondo: «Ha quattro piani. Suppongo che ogni piano sia alto circa cinque metri; quindi dev’essere alto più o meno venti metri».
2. In un altro caso: «So grossomodo come appare un metro a quella distanza; quindi sarà lungo all’incirca quattro metri».
3. Oppure ancora: «Posso immaginare che un uomo alto arrivi più o meno fino a lì; quindi, sarà circa un metro e ottanta dal suolo».
4. Oppure: «Non lo so; sembra proprio un metro».
Probabilmente, quest’ultimo caso ci sorprenderà. Se chiedi «cosa è accaduto in questo caso quando costui ha stimato la lunghezza?», la risposta corretta potrebbe essere «ha guardato l’oggetto e ha detto “sembra lungo un metro”». Potrebbe essere accaduto soltanto questo.
Abbiamo detto prima che, se il rabdomante ci avesse detto di aver imparato come misurare la profondità, la sua risposta |(Ts-309,18) non ci avrebbe lasciati perplessi. Parlando per approssimazioni, il fatto d’imparare a stimare può essere visto in due diverse relazioni rispetto all’atto dello stimare: o come causa del fenomeno dello stimare; oppure come qualcosa che ci fornisce una regola (una tabella, un grafico, o qualcosa di simile) che utilizziamo quando stimiamo.
Supponiamo che io insegni a qualcuno l’uso della parola «giallo» indicando ripetutamente una chiazza gialla e pronunciando la parola in questione. In un’altra occasione gli faccio applicare ciò che ha imparato dandogli l’ordine «prendi una palla gialla da questa borsa». Che cosa è successo quando ha obbedito all’ordine? Io dico: «Magari soltanto questo: ha sentito le mie parole e ha preso una palla gialla dalla borsa». Tu però potresti essere portato a pensare che non può affatto essersi trattato solo di questo; e il tipo di cosa che suggeriresti è che nel comprendere l’ordine lui avrebbe immaginato qualcosa di giallo; per poi scegliere una palla in base a tale immagine. Per vedere che ciò non è necessario, ricorda che avrei potuto dargli l’ordine «immagina una chiazza gialla». Saresti ancora incline a presumere che lui prima immagini una superficie gialla, solo comprendendo il mio ordine, e poi immagini una superficie gialla intonata alla precedente? (Ora, non dico che non sia possibile. Soltanto, metterla giù così ti mostra subito che ciò non deve succedere per forza. Questo, peraltro, illustra il metodo della filosofia.)
Se il significato della parola «giallo» ci viene insegnato dandoci una specie di definizione ostensiva (una regola dell’uso della parola), si può considerare tale insegnamento in due modi diversi.
A. L’insegnamento è un’esercitazione. A causa dell’esercitazione, noi |(Ts-309,19) associamo un’immagine gialla, cose gialle, con la parola «giallo». Dunque quando do l’ordine «prendi una palla gialla da questa borsa» la parola «giallo» può aver suscitato un’immagine gialla, oppure una sensazione di riconoscimento quando l’occhio della persona si è posato sulla palla gialla. In questo caso si potrebbe dire che l’esercitazione dell’insegnamento ha sviluppato un meccanismo psichico. Questa, comunque, sarebbe soltanto un’ipotesi o una metafora. Potremmo paragonare l’insegnamento all’installazione di una connessione elettrica tra un interruttore e una lampadina. Il parallelo con un difetto della connessione o con la sua rottura sarebbe ciò che chiamiamo dimenticarsi la spiegazione della parola. (Dovremo parlare più avanti del significato di «dimenticare il significato di una parola».)
Nella misura in cui l’insegnamento produce l’associazione, la sensazione di riconoscimento, ecc., ecc., esso è la causa dei fenomeni del comprendere, dell’obbedire, ecc.; e che il processo dell’insegnamento sia necessario per produrre tali effetti è un’ipotesi. È concepibile, in questo senso, che tutti i processi del comprendere, dell’obbedire, ecc. abbiano avuto luogo senza che alla persona sia mai stato insegnato il linguaggio. (Ciò, in questo momento, pare estremamente paradossale.)
B. L’insegnamento può averci fornito una regola che è essa stessa coinvolta nei processi del comprendere, dell’obbedire, ecc.; dove «coinvolta», però, significa che l’espressione di tale regola forma una parte di questi processi.
Dobbiamo distinguere tra ciò si potrebbe chiamare «processo che si svolge secondo una regola» e «un processo che coinvolge una regola» (nel senso di cui sopra). |(Ts-309,20)
Facciamo un esempio. Qualcuno mi insegna a elevare al quadrato i numeri cardinali; scrive la sequenza
1 2 3 4
e mi chiede di elevarli al quadrato. (In questo caso, nuovamente, rimpiazzerò qualunque processo avente luogo “nella mente” con processi di calcolo sul foglio.) Supponi che, sotto la prima sequenza di numeri, io poi scriva: –
1 4 9 16.
Quanto ho scritto è in accordo con la regola generale dell’elevamento al quadrato; ma ovviamente è in accordo anche con un gran numero di altre regole; e quanto a queste, non è più in accordo con una che con un’altra. Nel senso in cui prima abbiamo parlato di una regola coinvolta in un processo, in questo caso non è stata coinvolta alcuna regola. Supponiamo che per ottenere i miei risultati io abbia calcolato 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 (ovvero, in questo caso, che abbia scritto le operazioni); queste di nuovo sarebbero in accordo con un gran numero di regole. Supponiamo, d’altro canto, che per arrivare ai risultati io abbia scritto quella che si potrebbe chiamare «la regola dell’elevamento al quadrato», per esempio algebricamente. In tal caso questa regola sarebbe coinvolta in un senso in cui non lo è nessun’altra regola.
Diremo che la regola è coinvolta nel comprendere, nell’obbedire, ecc. se (per utilizzare quest’espressione) il simbolo della regola costituisce una parte del calcolo. (Non essendo interessati a dove i processi del pensare, del calcolare hanno luogo, possiamo, per i nostri scopi, immaginare che i calcoli vengano svolti interamente su carta. Non ci preoccupiamo della differenza: interno, esterno.) |(Ts-309,21)
Un esempio caratteristico del caso B sarebbe quello in cui l’insegnamento ci ha fornito una tabella di cui effettivamente facciamo uso nel comprendere, nell’obbedire, ecc. Se ci insegnano a giocare a scacchi, possono insegnarci regole. Se poi giochiamo a scacchi, queste regole non devono necessariamente essere coinvolte nell’atto del giocare. Però possono. Immagina, per esempio, che le regole fossero espresse in forma di tabella; in una colonna sono disegnate le forme dei pezzi, in una colonna parallela troviamo invece i diagrammi che mostrano la «libertà di movimento» (le mosse legittime) dei pezzi. Supponi ora che nel modo in cui si gioca sia coinvolto il fatto di operare sulla tabella la transizione dalla forma alle mosse possibili, per poi compiere una di queste mosse.
L’insegnamento come storia ipotetica delle nostre azioni successive (comprendere, obbedire, stimare una lunghezza, ecc.) scompare dalla nostra considerazione. La regola che ci hanno insegnato e che viene successivamente applicata ci interessa solo nella misura in cui è coinvolta nell’applicazione. Una regola, nella misura in cui ci interessa, non agisce a distanza.
Supponi che io indichi un pezzo di carta e dica a qualcuno: «Questo colore io lo chiamo “rosso”». In seguito, gli do l’ordine: «Dipingimi una chiazza rossa». Poi gli chiedo: «Perché, nell’eseguire l’ordine, l’hai dipinta proprio di questo colore?». Allora la sua risposta potrebbe essere: «Questo colore (indicando il campione che gli ho dato) era chiamato rosso; e la chiazza che ho dipinto ha, come vedi, il colore del campione». Ora mi ha fornito una ragione per aver eseguito l’ordine nel modo in cui l’ha eseguito. Fornire una ragione per qualcosa che si è fatto o detto significa mostrare un percorso che porta a |(Ts-309,22) tale azione. In alcuni casi significa raccontare il percorso che si è fatto in prima persona; in altri casi significa descrivere un percorso che conduce lì e che è in accordo con certe regole accettate. Quindi alla domanda «Perché, nell’eseguire l’ordine, hai usato proprio questo colore?» si potrebbe rispondere descrivendo il percorso effettivamente impiegato dalla persona per arrivare a questa tinta particolare. Si avrebbe una descrizione di questo genere se, sentendo la parola «rosso», lui avesse preso il campione che gli avevo dato, etichettato come «rosso», e poi, nel dipingere la superficie, l’avesse copiato. D’altro canto, avrebbe potuto dipingerlo «automaticamente» o in base a un’immagine mnemonica; ma quando gli fosse stata chiesta la ragione lui avrebbe comunque potuto indicare il campione e mostrare che s’intonava con la superficie appena dipinta. In quest’ultimo caso la ragione fornita sarebbe stata del secondo tipo; cioè, una giustificazione post hoc.
Se si pensa che non potrebbe darsi alcun comprendere o eseguire l’ordine senza un previo insegnamento, si pensa all’insegnamento come a ciò che fornisce una ragione per fare ciò che si è fatto; come a ciò che fornisce la strada su cui si cammina. Si ritiene che se un ordine viene compreso e poi eseguito dev’esserci una ragione per il fatto che viene eseguito nel modo in cui viene eseguito; anzi, una catena di ragioni che risale fino all’infinito. È come se si dicesse: «Ovunque tu sia, devi esserci arrivato da qualche altro luogo, e lì sei giunto da un altro luogo ancora; e così ad infinitum». (Se, d’altro canto, tu avessi detto «ovunque ti trovi, avresti potuto arrivarci da un altro luogo distante dieci metri; e lì da un terzo luogo, a sua volta distante dieci metri, e avanti così ad infinitum», ciò che tu invece avresti sottolineato sarebbe stata l’infinita possibilità di compiere un passo. Quindi |(Ts-309,23) l’idea di un’infinita catena di ragioni sorge da una conclusione simile a questa: – che una linea di una certa lunghezza consiste in un numero infinito di parti perché è divisibile indefinitamente; ossia, perché la possibilità di suddividerla non ha fine).
Se d’altro canto comprendi che la catena di ragioni effettive ha un inizio, non ti disgusterà più l’idea di un caso in cui non c’è alcuna ragione per il modo in cui hai eseguito l’ordine. A questo punto, comunque, subentra un’altra confusione, quella tra ragione e causa. A creare tale confusione è l’uso ambiguo della parola «perché». Quindi quando la catena di ragioni è giunta alla fine e la domanda «perché» continua a essere posta, allora si è portati a fornire una causa invece che una ragione. Se, per esempio, alla domanda, «perché hai usato questo colore quando ti ho detto di dipingere una superficie rossa» tu rispondi, «mi si è mostrato un campione di questo colore e al contempo mi è stata detta la parola “rosso”, e dunque ora, ogni volta che sento la parola “rosso”, mi si presenta alla mente questo colore», allora della tua azione hai fornito una causa invece che una ragione.
La proposizione secondo cui la tua azione ha avuto una causa così e così è un’ipotesi. L’ipotesi è fondata abbiamo avuto una serie di esperienze che, per dirla grossolanamente, concordano nel mostrare che la tua azione è il regolare seguito di certe condizioni che allora chiameremo cause dell’azione. Per conoscere la ragione per cui hai fatto una certa affermazione, hai agito in un particolare modo, ecc., non è necessaria alcuna serie di esperienze concordanti e l’affermazione della tua ragione non è un’ipotesi. La differenza tra le grammatiche di «ragione» e di «causa» è molto simile |(Ts-309,24) a quella tra le grammatiche di «movente» e di «causa». Della causa si può dire che non si può conoscerla ma soltanto fare congetture a riguardo. D’altra parte, si dice spesso: «Certo io lo so perché ho fatto così», riferendosi al movente. Quando dico: «Possiamo solo congetturare la causa ma conosciamo il movente», si vedrà in seguito che questa è un’affermazione grammaticale. Il «possiamo» si riferisce a una possibilità logica.
Il doppio uso della parola «perché», chiedere qual è la causa e chiedere qual è il movente, insieme all’idea che possiamo conoscere, e non solo congetturare, i nostri moventi, fa sorgere la confusione che un movente sia una causa di cui siamo immediatamente consapevoli, una causa «vista dall’interno», o una causa esperita. – Fornire una ragione è come fornire un calcolo per mezzo del quale sei arrivato a un certo risultato.
Torniamo all’affermazione secondo cui pensare essenzialmente consiste nell’operare con segni. Il punto principale è che se diciamo che pensare è un’attività mentale rischiamo di farci fuorviare. La domanda in merito a quale tipo di attività sia il pensare è analoga a questa: «Dove ha luogo il pensare?» Possiamo rispondere: sul foglio, nella nostra testa, nella mente. Nessuna di queste affermazioni di località fornisce la località del pensare. L’uso di tutte queste specificazioni è corretto, ma non dobbiamo farci fuorviare dalla somiglianza delle loro forme linguistiche, che ci condurrebbe altrimenti a una falsa concezione della loro grammatica. Come, per esempio, quando dici: «Certamente, il vero luogo del pensiero è nella nostra testa». Lo stesso vale per l’idea del pensare come attività. È corretto dire che pensare è un’attività della mano che scrive, della nostra laringe, della nostra testa, e |(Ts-309,25) della nostra mente, purché comprendiamo la grammatica di queste affermazioni. Ed è, inoltre, estremamente importante rendersi conto di come, fraintendendo la grammatica delle nostre espressioni, siamo portati a pensare che sia una in particolare di queste affermazioni a fornirci la vera sede dell’attività del pensare.
C’è un’obiezione all’affermazione che il pensare è qualcosa come un’attività della mano. Pensare, si vorrebbe dire, è parte della nostra «esperienza privata». Non è qualcosa di materiale, è un evento nella coscienza privata. Tale obiezione si esprime nella domanda: «Una macchina potrebbe pensare?». Di questo parlerò in seguito e ora ti rinvierò soltanto a una domanda analoga: «Una macchina può avere mal di denti?». A te certamente verrà da rispondere che «una macchina non può avere mal di denti». Adesso mi limiterò ad attirare la tua attenzione sull’uso che hai fatto della parola «può» e a chiederti: «Intendevi dire che tutta la nostra esperienza passata ci ha mostrato che nessuna macchina ha mai avuto mal di denti?». L’impossibilità di cui parli è di carattere logico. La domanda è: qual è la relazione tra pensare (o mal di denti) e il soggetto che pensa, ha mal di denti, ecc.? Per ora, a riguardo, non aggiungerò altro.
Se diciamo che pensare è essenzialmente operare con segni, la prima domanda che potresti porre è: «Cosa sono i segni?». – Invece di dare qualche tipo di risposta generale, ti proporrò di osservare attentamente dei casi particolari che dovremmo chiamare «operare con segni». Prendiamo un semplice esempio in cui si opera con parole. Do a qualcuno l’ordine «prendi sei mele dal fruttivendolo» e gli descrivo una maniera di fare uso |(Ts-309,26) di tale ordine: le parole «sei mele» sono scritte su un foglio, che viene passato al fruttivendolo, che confronta la parola «mela» con delle etichette su vari scaffali. Trova che concorda con una delle etichette, conta da 1 al numero scritto sul foglio e per ogni numero contato prende un frutto dallo scaffale e lo mette in un sacchetto. – Qui hai un uso di parole. In futuro continuerò ad attrarre la tua attenzione su ciò che chiamo giochi linguistici. Questi sono processi d’un uso dei segni ben più semplici di quelli che solitamente hanno luogo nell’uso del nostro complicatissimo linguaggio quotidiano. I giochi linguistici sono le forme di linguaggio con cui un bambino comincia a servirsi delle parole. Lo studio dei giochi linguistici è lo studio delle forme primitive del linguaggio o di linguaggi primitivi. Se vogliamo studiare i problemi della verità e della falsità, dell’accordo e del disaccordo delle proposizioni con la realtà, della natura dell’affermazione, della supposizione, dell’interrogazione, ci rivolgeremo con grande profitto a forme primitive di linguaggio in cui tali forme di pensiero appaiono senza lo sfondo sviante di processi di pensiero molto complicati. Quando guardiamo a queste semplici forme di linguaggio, si dissolve la nebbia mentale che sembra avvolgere il nostro uso ordinario del linguaggio. Scorgiamo attività, reazioni nette e trasparenti. D’altra parte riconosciamo in questi semplici processi forme di linguaggio non separate da una rottura dalle altre nostre forme più complicate. Ci accorgiamo di poter costruire le forme complicate a partire dalle primitive aggiungendo gradualmente nuove forme.
Ciò che ci rende difficile intraprendere una tale linea di ricerca |(Ts-309,27) è la nostra brama di generalità.
Questa brama di generalità è la risultante di varie tendenze connesse con particolari confusioni filosofiche. C’è –
a) La tendenza a cercare qualcosa di comune a tutte le entità che comunemente sussumiamo sotto un termine generale. – Siamo portati a pensare che ci debba essere qualcosa di comune a tutti i giochi, ad esempio, e che questa proprietà comune sia ciò che giustifica il fatto di applicare il termine generale «gioco» ai vari giochi; mentre i giochi formano una famiglia i cui membri presentano somiglianze familiari. Alcuni hanno lo stesso naso, altri le stesse sopracciglia e altri ancora la stessa andatura; e tali somiglianze si accavallano. L’idea che un concetto generale sia una proprietà comune a tutte le sue istanze particolari si ricollega ad altre idee primitive e troppo semplici circa la struttura del linguaggio. È paragonabile all’idea che le proprietà siano ingredienti delle cose che possiedono tali proprietà; per esempio, che la bellezza è un ingrediente di tutte le cose belle come l’alcol lo è della birra e del vino, e che dunque si potrebbe avere la bellezza pura, non adulterata da qualcosa di bello.
b) C’è una tendenza, radicata nelle nostre forme abituali di espressione, a pensare che l’uomo che ha imparato a comprendere un termine generale, per esempio il termine «foglia», è perciò arrivato a possedere una specie di immagine generale della foglia intesa come diversa dalle immagini di foglie particolari. Quando ha imparato il significato della parola «foglia», gli hanno mostrato diverse foglie; e mostrargli le foglie particolari era solo un mezzo per produrre «in lui» un’idea che immaginiamo essere una specie d’immagine generale. Diciamo che lui vede ciò che è comune |(Ts-309,28) a tutte queste foglie; ed è vero se intendiamo che, in risposta a un’eventuale domanda, può dirci certe caratteristiche o proprietà comuni a tali foglie. Ma noi siamo portati a pensare che l’idea generale di una foglia sia qualcosa come un’immagine visiva che però contenga solo ciò che è comune a tutte le foglie. (Fotografie composite di Galton.) Di nuovo, ciò si collega all’idea che il significato di una parola è un’immagine, o una cosa correlata alla parola. (Questo significa più o meno che guardiamo alle parole come se fossero tutte nomi propri e dunque confondiamo il portatore di un nome con il significato di un nome.)
c) Di nuovo la nostra idea di ciò che accade quando afferriamo l’idea generale di «foglia», «pianta» ecc. ecc. è connessa alla confusione tra uno stato mentale, inteso quale stato di un ipotetico meccanismo mentale, e uno stato mentale, inteso quale stato di coscienza (mal di denti, ecc.).
d) La nostra brama di generalità ha un’altra fonte principale: la nostra ossessione per il metodo della scienza. Mi riferisco al metodo di ridurre la spiegazione dei fenomeni naturali al minor numero possibile di leggi naturali primitive e, in matematica, di unificare il trattamento di argomenti diversi utilizzando una generalizzazione. I filosofi hanno costantemente sotto gli occhi il metodo della scienza e provano la tentazione irresistibile di porre domande e rispondervi nella maniera in cui lo fa la scienza. Questa tendenza è la vera fonte della metafisica e conduce il filosofo nell’oscurità più completa. Voglio dire qui che il nostro lavoro non può mai consistere nel ridurre nulla ad alcunché, o nello spiegare niente. La filosofia è davvero «puramente descrittiva». (Pensa a domande quali «Ci sono dati dei sensi?». |(Ts-309,29) E chiedi: che metodo c’è per determinarlo? L’introspezione?)
Invece di «brama di generalità» avrei potuto dire «l’atteggiamento sprezzante nei confronti del caso particolare». Se per esempio qualcuno, cercando di spiegare il concetto di numero, ci dice che la tale definizione non va bene o è zoppicante perché vale soltanto, poniamo, per i cardinali finiti, io risponderei che il semplice fatto che egli abbia potuto fornire una tale definizione limitata rende la definizione in questione estremamente importante per noi. (L’eleganza non è il nostro obiettivo.) Perché infatti dovrebbe interessarci maggiormente ciò che i numeri finiti e transfiniti hanno in comune rispetto a ciò invece che li distingue? Anzi, non avrei dovuto dire «perché dovrebbe interessarci maggiormente?» – non è così; e ciò caratterizza il nostro modo di pensare.
L’atteggiamento nei confronti di ciò che è più generale e l’atteggiamento nei confronti di ciò che è più speciale, in logica, sono connessi all’uso della parola «tipo», che può generare confusione. Parliamo di tipi di numeri, tipi di proposizioni, tipi di dimostrazioni; e anche di tipi mele, tipi di carta, ecc. In un senso, ciò che definisce il tipo sono delle proprietà, come la dolcezza, la durezza, ecc. In un altro senso, i diversi tipi sono diverse strutture grammaticali. Un trattato di pomologia può venire detto incompleto se esiste un qualche tipo di mela che non vi figura. Ecco uno standard di completezza in ambito naturalistico. Supponiamo d’altro canto che ci sia un gioco simile agli scacchi ma più semplice, in cui non vengono usati i pedoni. Dovremmo considerare un tale gioco incompleto? Oppure dovremmo considerarlo un gioco «più completo degli scacchi», che in qualche modo contiene gli scacchi ma vi ha aggiunto nuovi elementi? Il disprezzo per ciò che pare essere il caso meno generale, in logica, sorge dall’idea che sia incompleto. |(Ts-309,30) In effetti genera confusione il fatto di parlare dell’aritmetica cardinale come di qualcosa di semplice in contrapposizione a qualcosa di più generale. L’aritmetica cardinale non reca alcun marchio d’incompletezza; e nemmeno un’aritmetica che sia cardinale e finita. (Tra forme logiche non ci sono distinzioni sottili come tra i sapori di diversi tipi di mele.)
Se studiamo la grammatica, per esempio, delle parole «desiderare», «pensare», «comprendere», «intendere», una volta descritti vari casi di desiderare, pensare, ecc. non saremo insoddisfatti. Se qualcuno dicesse «di sicuro questo non esaurisce ciò che chiama “desiderare”», noi dovremmo rispondergli «certamente no, ma se vuoi puoi sviluppare altri casi più complicati». Dopo tutto, non c’è una classe definita di elementi che caratterizzano tutte le istanze del desiderare (almeno non per come si impiega comunemente tale parola). Se però vuoi fornire una definizione del desiderare, ossia tracciare un confine netto, allora sei libero di tracciarlo come ti aggrada; ma tale confine non coinciderà mai interamente con l’uso effettivo, perché quest’uso non ha un confine netto.
L’idea che per chiarire il significato di un termine generale si debba trovare l’elemento comune a tutte le sue applicazioni ha incatenato l’indagine filosofica; oltre a non aver prodotto alcun risultato, ha portato il filosofo ad accantonare in quanto irrilevanti tutti i casi concreti, che invece erano la sola cosa in grado di aiutarlo a comprendere l’uso del termine generale. Quando Socrate chiede «che cos’è la conoscenza?», non considera nemmeno una risposta preliminare il fatto di elencare i casi di conoscenza. Se io volessi scoprire che genere di cosa è l’aritmetica, sarei già ben soddisfatto di aver investigato il caso di un’aritmetica |(Ts-309,31) finita cardinale. Perché
a) questo mi porterebbe a tutti i casi più complicati;
b) un’aritmetica cardinale finita non è incompleta, non ha buchi che vengono poi riempiti dal resto dell’aritmetica.
Cosa succede se dalle 4 alle 4:30 A si aspetta che B venga nella sua stanza? In un senso in cui è usata l’espressione «aspettarsi qualcosa dalle 4 alle 4:30», certamente essa non si riferisce a un processo o stato mentale che prosegue per tutto il lasso di tempo in questione, bensì consiste in un gran numero di attività e di stati della mente diversi. Se per esempio io mi aspetto che B arrivi per il tè, ciò che accade può essere questo: alle quattro in punto guardo l’agenda e vedo il nome «B» alla data di oggi; preparo il tè per due persone; per un attimo penso «B fuma?» e tiro fuori delle sigarette; verso le 4.30 comincio a essere impaziente; immagino l’aspetto che avrà B nell’entrare nella mia stanza. Tutto ciò si chiama «aspettarsi B dalle 4 alle 4:30». E ci sono infinite variazioni di questo processo, tutte descritte dalla stessa espressione. Se si chiede che cos’hanno in comune i vari processi di aspettarsi che qualcuno venga per il tè, la risposta è che non c’è un singolo elemento comune a tutti questi processi, ma ci sono molti elementi che si accavallano. Tali istanze dell’aspettativa formano una famiglia; presentano somiglianze familiari che non sono chiaramente definite.
C’è un uso totalmente diverso della parola «aspettativa» quando la utilizziamo per intendere una sensazione particolare. Tale impiego di parole come «desiderio», «aspettativa», ecc. ci si suggerisce prontamente da solo. C’è una connessione ovvia tra quest’uso e quello descritto sopra. Non c’è dubbio che in molti casi, se ci aspettiamo l’arrivo di qualcuno, alcune o tutte le attività descritte sono accompagnate da una sensazione particolare, una tensione; ed è naturale |(Ts-309,32) utilizzare la parola «aspettativa» per intendere tale esperienza di tensione.
Sorge allora una domanda: questa sensazione va chiamata «la sensazione dell’aspettativa» oppure «la sensazione dell’aspettativa che B arrivi»? Nel primo caso affermare che sei in uno stato di aspettativa effettivamente non descrive appieno la situazione dell’aspettarsi che la tal cosa accada. Il secondo caso viene spesso frettolosamente addotto come spiegazione dell’impiego della locuzione «aspettarsi che la tal cosa succeda», e potresti persino pensare che una spiegazione simile ti metta al sicuro, poiché ogni ulteriore domanda si sistemerà dicendo che la sensazione dell’aspettativa è indefinibile.
In realtà non ci sono obiezioni contro il fatto di chiamare una sensazione particolare «l’aspettativa dell’arrivo di B». Potrebbero addirittura esserci buone ragioni pratiche per impiegare tale espressione. Fa’ attenzione, però: – se abbiamo spiegato il significato della locuzione «aspettarsi l’arrivo di B» in questo modo, non risulterà perciò spiegata nessun’altra locuzione che venga derivata dalla prima sostituendo a «B» un nome diverso. Si potrebbe dire che la locuzione «aspettarsi l’arrivo di B» non è il valore di una funzione «aspettarsi l’arrivo di x». Per comprenderlo, confronta il nostro caso con quello del funzionale «mangio x». Capiamo la proposizione «mangio una sedia» anche se non ci è stato mai insegnato nello specifico il significato dell’espressione «mangiare una sedia».
Il ruolo giocato nel presente caso dal nome «B» nell’espressione «mi aspetto B» può essere paragonato a quello giocato dal nome «Bright» nell’espressione «malattia di Bright». Confronta la grammatica di questa parola, quando denota un tipo particolare di malattia, con quella dell’espressione «malattia di Bright», quando |(Ts-309,33) significa la malattia da cui Bright è affetto. Caratterizzerò la differenza dicendo che la parola «Bright» nel primo caso è un indice nel nome complesso «malattia di Bright»; nel secondo caso la considererò un argomento della funzione «malattia di x». Si potrebbe dire che un indice allude a qualcosa e che tale allusione può essere giustificata in vari modi. Quindi chiamare una sensazione «l’aspettativa che B arrivi» consiste nel darle un nome complesso e «B» potrebbe alludere all’uomo la cui venuta è stata abitualmente preceduta da tale sensazione.
Di nuovo, possiamo usare l’espressione «aspettativa che B arrivi» non come un nome ma come una caratteristica di certe sensazioni. Potremmo, per esempio, spiegare che una certa tensione è considerata un’aspettativa dell’arrivo di B se viene allentata dall’arrivo di B. Se è così che impieghiamo questa locuzione, allora è vero che non sappiamo ciò che ci aspettiamo fino a quando la nostra aspettativa è stata soddisfatta (cfr. Russell). Nessuno però può credere che questo sia l’unico modo o anche solo il più comune di utilizzare la parola «aspettarsi». Se chiedo a qualcuno «chi ti aspetti?» e dopo aver ricevuto la risposta gli chiedo «sei sicuro che non ti aspetti invece qualcun altro?», nella maggior parte casi quest’ultimo interrogativo sarebbe considerato assurdo e la risposta sarebbe qualcosa sulla falsariga di «certo, non posso non sapere chi mi aspetto».
Si può caratterizzare il significato che Russell dà alla parola «desiderare» dicendo che per lui significa una specie di fame. – Che una particolare sensazione di fame sarà alleviata dal mangiare una certa cosa è un’ipotesi. Nel modo in cui Russell utilizza la parola «desiderare» non ha senso dire «desideravo una mela ma una pera mi ha soddisfatto». Talvolta però ci esprimiamo così, |(Ts-309,34) utilizzando la parola «desiderare» in maniera diversa da Russell. In questo senso possiamo dire che la tensione del desiderare è stata alleviata senza il soddisfacimento del desiderio; e anche che il desiderio è stato soddisfatto senza che si sia alleviata la tensione. Cioè è possibile, in questo senso, che io divenga soddisfatto senza che il mio desiderio sia stato soddisfatto.
Si potrebbe essere tentati di dire che la differenza di cui stiamo parlando si riduce semplicemente al fatto che in certi casi sappiamo ciò che desideriamo e in altri no. Indubbiamente ci sono casi in cui diciamo «ho voglia, ma non so di cosa ho voglia» oppure «ho paura, ma non so di cos’ho paura», oppure ancora: «ho paura, ma non ho paura di nulla in particolare». |(Ts-309,35)
Possiamo descrivere questi casi dicendo che abbiamo certe sensazioni che non si riferiscono a oggetti. La locuzione «non si riferiscono a oggetti» introduce una distinzione grammaticale. Se nel caratterizzare tali sensazioni usiamo locuzioni verbali come «avere paura», «avere voglia», ecc., queste saranno intransitive; «ho paura» sarà analogo a «piango». Possiamo piangere per qualcosa, ma ciò per cui piangiamo non è un elemento costitutivo del processo di piangere; ovverosia, potremmo descrivere tutto ciò che accade mentre piangiamo senza fare menzione di ciò per cui piangiamo.
Supponiamo ora che io suggerisca di utilizzare l’espressione «provo paura» e altre simili soltanto in maniera transitiva. Ovunque prima dicevamo (intransitivamente) «ho una sensazione di paura», adesso diremo «ho paura di qualcosa, ma non so di cosa». Esistono obiezioni a questa fraseologia?
Potremmo dire: «No, fatto salvo che in tal caso usiamo la parola “sapere” in maniera bizzarra». Considera il caso seguente: – abbiamo una sensazione generale, priva di direzioni, di paura. Successivamente ci capita un’esperienza che ci fa dire: «Ora so di cos’avevo paura. Avevo paura che accadesse questa e questa cosa». È corretto descrivere la mia prima sensazione con un verbo intransitivo, oppure dovrei dire che la mia paura aveva un oggetto, anche se io ignoravo che l’avesse? |(Ts-309,36) Possono essere impiegate entrambe queste forme di descrizione. Per capirlo, esamina gli esempi seguenti: – potrebbe risultare pratico chiamare un certo stato di decadimento dentale, non accompagnato da ciò che chiamiamo comunemente mal di denti, «mal di denti inconscio» e utilizzare in tal caso l’espressione che abbiamo mal di denti, ma non lo sappiamo. È proprio in questo senso che la psicanalisi parla di pensieri inconsci, atti di volizione inconsci, ecc. È dunque sbagliato in questo senso dire che ho mal di denti ma non lo so? Non è affatto sbagliato, perché si tratta soltanto di una nuova terminologia, che può essere ritradotta in qualsiasi momento nel linguaggio ordinario. D’altra parte, è evidente che qui si fa un uso nuovo della parola «sapere». Se vuoi esaminare come viene usata tale espressione, ti sarà utile chiederti: «Che aspetto ha in questo caso il processo di venire a sapere?», «Che cos’è che chiamiamo “venire a sapere” o “scoprire”?».
Non è sbagliato, secondo la nostra nuova convenzione, dire «ho un mal di denti inconscio». Che cosa si può chiedere di più alla nostra notazione, che così distingue tra un dente malandato che ti dà il mal di denti e uno che non te lo dà? Ma la nuova espressione ci fuorvia richiamando immagini e analogie che ci rendono difficile andare fino in fondo con la nostra convenzione. Ed è difficilissimo ignorare |(Ts-309,37) tali immagini, a meno di non esercitare una vigilanza costante; particolarmente difficile quando, filosofando, contempliamo ciò che diciamo sulle cose. Dunque, davanti all’espressione «mal di denti inconscio», puoi essere condotto a pensare erroneamente che sia stata fatta una scoperta magnifica, una scoperta che in un certo senso sconvolge completamente la nostra comprensione; oppure puoi giungere a una perplessità estrema nei confronti di tale espressione (la perplessità filosofica) e magari porre domande quali: «Come è possibile un mal di denti inconscio?». Potresti allora essere portato a rifiutare la possibilità del mal di denti inconscio; ma lo scienziato ti dirà che si tratta di un fatto dimostrato e te lo dirà come un uomo intento a distruggere il pregiudizio comune. Ti dirà: «È davvero semplicissimo; ci sono altre cose di cui non sei a conoscenza, e può esistere anche un mal di denti di cui non sei a conoscenza. È soltanto una nuova scoperta». Tu resterai insoddisfatto, ma non saprai cosa rispondere. Questa situazione, tra scienziati e filosofi, si verifica costantemente.
In un caso simile potremmo chiarire la faccenda dicendo: «Vediamo come la parola “inconscio”, “sapere”, ecc. ecc., è usata in questo caso e come è usata in altri casi». Quanto in là si spinge l’analogia tra questi due casi? Cercheremo anche di costruire nuove notazioni, in modo da rompere l’incantesimo di quelle a cui siamo abituati.
Abbiamo detto che chiederci che cosa, nel caso particolare che stiamo esaminando, dovremmo chiamare «venire a sapere» era un modo di esaminare la grammatica (l’uso) della parola «sapere». Si ha |(Ts-309,38) la tentazione di pensare che questa domanda sia soltanto vagamente pertinente, sempre che lo sia, rispetto alla domanda «che cosa significa la parola “sapere”?». Quando chiediamo «che aspetto ha in questo caso il “venire a sapere?”» sembra che ci siamo fatti sviare. Ma tale domanda è davvero una domanda riguardante la grammatica della parola «sapere», e ciò diventa più chiaro se la mettiamo nella forma: «Che cosa chiamiamo “venire a sapere?”». È parte della grammatica della parola «sedia» che questo sia ciò che chiamiamo «stare seduti su una sedia» ed è parte della grammatica della parola «significato» che questo sia ciò che chiamiamo «spiegazione di un significato»; analogamente, spiegare il mio criterio per il mal di denti a un’altra persona è fornire una spiegazione grammaticale sulla locuzione «mal di denti» e, in questo senso, «una spiegazione in merito al significato della locuzione “mal di denti”».
Quando abbiamo imparato il significato dell’espressione «il tal dei tali ha mal di denti», ci sono stati indicati certi tipi di comportamento di coloro che si diceva avessero mal di denti. Come esempio di tali tipi di comportamento, prendiamo l’atto di tenersi la guancia. Supponi che, osservando, io abbia scoperto che in certi casi, ogni volta che questi primi criteri mi dicevano che qualcuno aveva mal di denti, sulla sua guancia compariva una macchia rossa. Supponi che io dica ora a qualcuno: «Vedo che A ha mal di denti, ha una macchia rossa sulla guancia». Quello mi potrebbe chiedere: «Come fai a sapere che A ha mal di denti quando vedi una macchia rossa?». Io dovrei fargli presente che certi fenomeni hanno sempre coinciso con la comparsa della macchia rossa.
A questo punto, allora, si potrebbe chiedere: «Come fai a sapere che ha |(Ts-309,39) mal di denti quando si tiene la guancia?». Qui la risposta potrebbe essere: «Dico che lui ha mal di denti quando si tiene la guancia perché io mi tengo la guancia quando ho mal di denti». E se però proseguissimo domandando: – «E come mai supponi che il mal di denti corrisponde al fatto che lui si tiene la guancia solo perché il tuo mal di denti corrisponde al fatto che tu ti tenga la guancia?». Non sapresti come rispondere a una simile domanda e si scopriresti che abbiamo toccato il fondo, ossia siamo scesi fino alle convenzioni. (Se per rispondere all’ultima domanda suggerisci che ogni volta che hai visto delle persone tenersi la guancia e hai chiesto loro «che cosa c’è?» loro ti hanno risposto «ho mal di denti», – ricorda che quest’esperienza coordina soltanto il gesto di tenerti la guancia con il fatto di dire certe parole.)
Introduciamo due termini antitetici per evitare certe confusioni elementari. Alla domanda «come sai che le cose stanno così e così?» rispondiamo talvolta fornendo «criteri» e talvolta fornendo «sintomi». Se la scienza medica chiama angina un’infiammazione causata da un particolare germe e in un determinato caso noi chiediamo «perché dici che quest’uomo ha l’angina?», allora la risposta «ho trovato il tale germe nel suo sangue» ci fornisce il criterio dell’angina, o ciò che potremmo chiamare il suo criterio di definizione. Se però la risposta fosse «ha la gola infiammata», ciò potrebbe fornirci un sintomo dell’angina. Chiamo «sintomo» un fenomeno di cui l’esperienza ci ha insegnato la coincidenza, in un modo o nell’altro, con il fenomeno che è il nostro criterio di definizione. Allora dire «un uomo ha l’angina» se gli si trova il tale germe è una tautologia |(Ts-309,40) o un modo approssimativo di dare una definizione di «angina». Ma dire «un uomo ha l’angina ogni volta che ha la gola infiammata» è fare un’ipotesi.
Nella pratica, se ti chiedessero quale fenomeno è il criterio di definizione e quale è un sintomo, nella maggior parte dei casi tu non saresti in grado di rispondere a meno di non compiere una decisione arbitraria ad hoc. Può essere pratico definire una parola prendendo un fenomeno come criterio di definizione, ma sarebbe facile persuaderci a definire una parola per mezzo di ciò che, secondo il nostro primo impiego, era un sintomo. I medici usano i nomi delle malattie senza mai decidere quali fenomeni vanno presi come criteri e quali come sintomi; e questa non è per forza una deplorevole carenza di chiarezza. Ricorda infatti che in generale non utilizziamo il linguaggio seguendo regole stringenti – né il linguaggio ci è stato insegnato per mezzo di regole stringenti. Noi, d’altro canto, nelle nostre discussioni, confrontiamo costantemente il linguaggio con un calcolo che procede secondo regole esatte.
È questa una prospettiva molto unidirezionale sul linguaggio. Nella pratica è rarissimo che ci serviamo del linguaggio come di un tale calcolo. Non solo non pensiamo alle regole d’uso – alle definizioni, ecc. – mentre usiamo il linguaggio; quando ci si chiede di fornire tali regole, nella maggior parte dei casi non siamo in grado di farlo. Siamo incapaci di circoscrivere chiaramente i concetti che impieghiamo; non perché non conosciamo le loro vere definizioni, ma perché essi non hanno una vera «definizione». Supporre che debba esserci sarebbe come suppore che ogni volta che i bambini giocano con un pallone giochino |(Ts-309,41) un gioco dotato di regole stringenti.
Quando parliamo del linguaggio come di un simbolismo utilizzato in un calcolo esatto, ciò che abbiamo in mente può essere rinvenuto nella scienza e nella matematica. Il nostro uso ordinario del linguaggio si conforma a tale standard di esattezza solo in casi rari. Perché allora filosofando confrontiamo costantemente il nostro uso delle parole con un uso che segue regole esatte? La risposta è che gli enigmi che cerchiamo di rimuovere sorgono sempre proprio da questa attitudine verso il linguaggio.
Considera per esempio la domanda «che cos’è il tempo?» come l’hanno posta Sant’Agostino e altri. A un primo sguardo ciò che la domanda esige è una definizione, ma poi subito spunta l’interrogativo: «Che cosa guadagneremmo da una definizione, se essa può solo condurci ad altri termini non definiti?». E perché dovrebbe sconcertarci soltanto l’assenza di una definizione del tempo e non l’assenza di definizione di «sedia»? Perché non dovremmo essere sconcertati in tutti i casi in cui non abbiamo una definizione? Spesso una definizione chiarisce la grammatica di una parola. E in effetti è la grammatica della parola «tempo» a sconcertarci. Per esprimere tale sconcerto poniamo una domanda leggermente fuorviante: «Che cos’è…?». Questa domanda è una manifestazione di confusione, di malessere mentale; è paragonabile alla domanda «perché?» come la fanno spesso i bambini. Anche questa è un’espressione di malessere mentale e non chiede necessariamente una causa o una ragione. (Hertz, Principi della meccanica.) La perplessità per la grammatica della parola |(Ts-309,42) «tempo» sorge da quelle che potremmo chiamare contraddizioni apparenti di tale grammatica.
Era una tale «contraddizione» a sconcertare Sant’Agostino quando egli argomentava: come è possibile che si misuri il tempo? Il passato infatti, essendo passato, non può essere misurato; il futuro non può essere misurato perché deve ancora venire. E il presente non può essere misurato perché non ha estensione.
La contraddizione che sembra sorgere qui potrebbe essere chiamata un conflitto tra due diversi utilizzi di una parola, in questo caso la parola «misurazione». Agostino, diremmo, pensa al processo di misurare una lunghezza: per esempio, la distanza tra due tacche su una fascia semovente che ci soprassa e di cui davanti a noi possiamo scorgere solo una piccola parte (il presente). Risolvere questo enigma consisterà nel confrontare ciò che chiamiamo «misurazione» (la grammatica della parola «misurazione»), quando viene applicata alla distanza segnata su una fascia semovente, con la grammatica di tale parola, quando viene applicata al tempo. Il problema può sembrare semplice, ma la sua estrema difficoltà è dovuta al fascino che esercita su di noi l’analogia tra due strutture simili nel nostro linguaggio. (Qui è utile ricordare che talvolta a un bambino risulta quasi impossibile comprendere che una parola può avere due significati.)
Ora è chiaro che questo problema inerente al concetto di tempo richiede una risposta in forma di regole stringenti. L’enigma riguarda le regole. – Ecco un altro esempio: la domanda socratica: «Che cos’è la conoscenza?». Qui il caso è ancora più chiaro, poiché la discussione comincia con il discepolo che fornisce un esemplare di |(Ts-309,43) definizione esatta; e poi, analogamente, viene chiesta una definizione della parola «conoscenza». Da come è posta la questione, sembra che ci sia qualcosa di sbagliato nell’uso ordinario della parola «conoscenza». Parrebbe che non sappiamo cosa significhi e che dunque, forse, non abbiamo il diritto di impiegarla. Dovremmo rispondere: «Non c’è un singolo uso esatto della parola “conoscenza”; possiamo però escogitare diversi di questi utilizzi, che più o meno concorderanno con i modi in cui la parola viene effettivamente usata».
Colui che è filosoficamente perplesso scorge una legge nel modo in cui è usata una parola e, nel tentativo di applicare tale legge in modo del tutto coerente, si scontra con dei casi nei quali ciò conduce a risultati paradossali. Molto spesso, la discussione di un tale enigma si svolge in questo modo: prima si pone la domanda: «Che cos’è il tempo?». La domanda fa sembrare che ciò che vogliamo sia una definizione. Erroneamente pensiamo che una definizione sia ciò che rimuoverà l’inciampo; come in certi casi d’indigestione avvertiamo una specie di fame che non si può placare mangiando. Alla domanda si risponde poi con una definizione sbagliata; per esempio: «Il tempo è il moto dei corpi celesti». Il passo successivo è accorgersi che tale definizione è insoddisfacente. Ciò però significa soltanto che non impieghiamo la parola «tempo» come sinonimo di «moto dei corpi celesti». Comunque, dicendo che la prima definizione è sbagliata, siamo tentati di pensare di doverla rimpiazzare con un’altra definizione, quella corretta.
Confronta con questo caso il caso della definizione del numero. Qui la spiegazione che un numero è la stessa cosa di un numerale soddisfa quella brama di una definizione. Ed è molto |(Ts-309,44) difficile non chiedere: «Be’, se non è il numerale, che cos’è?».
La filosofia, per come usiamo noi questa parola, è una lotta contro il fascino che le forme di espressione esercitano su di noi.
Ricorda che le parole hanno i significati che abbiamo dato loro; e noi diamo loro significati per mezzo di spiegazioni. Posso aver fornito una definizione di una parola e poi aver usato tale parola di conseguenza, oppure chi mi ha insegnato l’uso della parola può avermi fornito la spiegazione. Oppure, con spiegazione di una parola potremmo intendere la spiegazione che, se ci venisse chiesto, saremmo pronti a dare. Se, cioè, siamo pronti a dare una spiegazione; nella maggior parte dei casi, non lo siamo. Molte parole quindi in questo senso non hanno un significato stringente. Questo però non è un difetto. Pensare che lo sia sarebbe come dire che la luce del mio abat-jour non è vera luce perché non ha un confine netto.
I filosofi molto spesso parlano di investigare, analizzare i significati delle parole. Non dimentichiamo però che una parola non ha un significato attribuitole, per così dire, da un potere indipendente da noi, così che possa esserci una specie di indagine scientifica di ciò che la parola davvero significa. Una parola ha il significato che qualcuno le ha dato.
Ci sono parole con vari significati chiaramente definiti. È facile tabulare tali significati. E ci sono parole di cui si potrebbe dire: sono utilizzate in mille modi diversi che gradualmente si fondono l’uno nell’altro. Non c’è da meravigliarsi se per il loro impiego non riusciamo a tabulare regole stringenti. |(Ts-309,45)
È sbagliato dire che in filosofia consideriamo un linguaggio ideale come opposto a quello ordinario. Ciò fa sembrare che pensiamo di poter migliorare il linguaggio ordinario. Ma il linguaggio ordinario va bene. Ogni volta che inventiamo «linguaggi ideali» non lo facciamo per sostituirli al linguaggio ordinario; ma soltanto per rimuovere certi intralci, causati nella mente di qualcuno dal pensiero di essere riuscito ad afferrare l’uso esatto di una parola comune. Ed è per questo anche che il nostro metodo non consiste solo nell’elencare gli utilizzi effettivi delle parole, bensì nell’inventarne apposta di nuovi, alcuni dei quali proprio in virtù della loro apparenza assurda.
Quando diciamo che con il nostro metodo cerchiamo di contrastare l’effetto fuorviante di certe analogie, è importante che tu capisca che l’idea secondo cui un’analogia è fuorviante non è definita in maniera stringente. Non si può tirare alcun confine netto attorno ai casi in cui diremmo che un uomo è stato fuorviato da un’analogia. L’uso di espressioni costruite su schemi analogici sottolinea analogie tra casi spesso ben distanti l’uno dall’altro. Proprio per questo, tali espressioni possono essere di grande utilità. Nella maggior parte dei casi, è impossibile mostrare il punto preciso in cui un’analogia comincia a fuorviarci. Ogni notazione particolare sottolinea un qualche punto di vista particolare. Se, per esempio, chiamiamo le nostre ricerche «filosofia», tale titolo da un lato sembra consono, ma dall’altro ha anche di certo fuorviato qualcuno. (Si potrebbe dire che l’argomento di cui ci occupiamo è uno degli eredi di ciò che un tempo chiamavamo «filosofia».) I casi in cui desideriamo particolarmente affermare che qualcuno |(Ts-309,46) è fuorviato da una forma d’espressione sono quelli in cui diremmo: «Non parlerebbe in questo modo se fosse consapevole di questa differenza nella grammatica di queste e queste parole, o se fosse consapevole di quest’altra possibilità di espressione» e avanti così. Dunque potremmo dire che ovviamente alcuni matematici che filosofeggiano non sono consapevoli della differenza tra i molti diversi impieghi della parola «prova»; e che, quando parlano di tipi di numeri, tipi di prove, come se la parola «tipo» qui significasse la stessa cosa che nel contesto «tipi di mele», essi non hanno chiara la differenza tra i molti utilizzi diversi della parola «tipo». Oppure potremmo dire che non sono consapevoli dei diversi significati della parola «scoperta», quando in un caso ci si riferisce alla scoperta della costruzione del pentagono e nell’altro caso alla scoperta del Polo Sud.
Nel distinguere un uso transitivo e un uso intransitivo di locuzioni quali «desiderare», «temere», «aspettarsi», ecc., abbiamo detto che qualcuno potrebbe provare a appianare le nostre difficoltà affermando: «La differenza tra i due casi è semplicemente che in uno sappiamo che cosa desideriamo e nell’altro no». Chi dice così, naturalmente, non vede che, quando esaminiamo attentamente l’uso della parola «sapere» nei due casi, la differenza che cercava di risolvere con la propria spiegazione ricompare. L’espressione «la differenza è semplicemente…» ci dà l’impressione di aver analizzato il caso e trovato un’analisi semplice; come quando mettiamo in rilievo il fatto che due sostanze dai nomi molto diversi hanno composizione quasi identica. |(Ts-309,47)
In questo caso abbiamo detto che potremmo usare entrambe le espressioni «sentiamo di desiderare» (dove «desiderare» è usato intransitivamente) e «sentiamo di desiderare e non sappiamo cosa desideriamo». Dire che possiamo usare correttamente due forme d’espressione che sembrano contraddirsi può sembrare strano; ma tali casi sono molto frequenti.
Usiamo il seguente esempio per chiarire la questione. Diciamo che l’equazione x² = −1 ha la soluzione ± √−1. Un tempo si diceva che tale equazione fosse priva di soluzioni. Ora questa affermazione, che concordi o meno con quella che ci ha fornito le soluzioni, certamente non ha la stessa molteplicità. Ma possiamo facilmente conferirle tale molteplicità affermando che un’equazione x² + 2ax + b = 0 non ha soluzione ma giunge alla distanza α dalla soluzione più vicina, che è β. Analogamente, possiamo dire o che «una retta interseca sempre una circonferenza; talvolta in punti reali, talvolta in punti complessi», o che «una retta o interseca una circonferenza, oppure non la interseca e giunge a una distanza α dal farlo». Queste due affermazioni hanno esattamente lo stesso significato. Saranno più o meno soddisfacenti a seconda del modo in cui si desidera guardare la cosa. Si potrebbe voler rendere la differenza tra intersecare e non intersecare quanto meno evidente possibile. Oppure si potrebbe volerla mettere in luce. Entrambe le tendenze possono essere giustificate, per esempio, da particolari scopi pratici. Ma questa può non essere affatto la ragione per cui si preferisce una forma di espressione all’altra. Quale forma si preferisce, e se si ha una preferenza o no, spesso dipende da tendenze generali e profondamente radicate |(Ts-309,48) del proprio pensare.
Dovremmo dire che ci sono casi in cui un uomo disprezza un altro uomo e non lo sa; oppure dovremmo descrivere tali casi dicendo che non lo disprezza ma, senza volerlo, si comporta nei suoi confronti in un modo – gli parla in un tono di voce, ecc. – che in generale accompagnerebbe il fatto di disprezzarlo? Entrambe le forme d’espressione sono corrette; ma possono tradire tendenze diverse della mente.
Torniamo a esaminare la grammatica delle espressioni «desiderare», «aspettarsi», «avere voglia di», ecc., e consideriamo il caso fondamentale in cui l’espressione «desidero che la tal cosa succeda» è la descrizione diretta di un processo cosciente. Ovverosia, il caso in cui saremmo propensi a rispondere alla domanda «sei sicuro che è questo che desideri?» con «certo, devo saperlo che cos’è che desidero». Adesso confronta questa risposta con quella che molti di noi darebbero alla domanda: «conosci l’ABC?». L’affermazione enfatica che conosci l’ABC ha qui un senso analogo a quello dell’asserzione precedente? Entrambe le asserzioni in un certo senso rifiutano la domanda. Ma la prima non dice «certo che so una cosa tanto semplice», bensì: «la domanda che mi hai posto non ha senso». Potremmo dire: adottiamo in questo caso un metodo errato di rifiutare la domanda. «Certo che lo so» qui potrebbe essere rimpiazzato da «certo, non ci sono dubbi» e questo potrebbe venir interpretato come «in questo caso, non ha senso parlare di dubbi». In tal modo la risposta «certo che lo so che cosa desidero» può essere |(Ts-309,49) interpretata come un’affermazione grammaticale.
Sarebbe simile se chiedessimo «questa stanza ha una lunghezza?» e qualcuno rispondesse «certo che ce l’ha». Avrebbe potuto risponderci: «Non fare domande senza senso». D’altra parte «la stanza ha una lunghezza» può fungere da affermazione grammaticale. In questo caso dice che una frase della forma di «la stanza è lunga – metri» ha senso.
Moltissime difficoltà filosofiche si ricollegano a quel senso delle espressioni «desiderare», «pensare», ecc., di cui ci stiamo occupando adesso. Queste difficoltà possono tutte venire riassunte dalla domanda: «Come si può pensare ciò che non accade?».
Questo è un ottimo esempio di domanda filosofica. Ci chiede «come si fa a…?» e, anche se ciò ci sconcerta, dobbiamo ammettere che non c’è nulla di più facile che pensare ciò che non accade. Intendo che questo ci mostra nuovamente che la difficoltà in cui ci troviamo non sorge dalla nostra incapacità di immaginare come si fa a pensare qualcosa; proprio come la difficoltà filosofica inerente alla misurazione del tempo non sorgeva a partire dalla nostra incapacità di immaginare come il tempo veniva effettivamente misurato. Lo dico perché talvolta sembra quasi che la nostra difficoltà consista nel ricordare esattamente che cosa è successo quando abbiamo pensato qualcosa, che sia una difficoltà d’introspezione, o qualcosa di simile; mentre in realtà la difficoltà sorge quando guardiamo ai fatti attraverso il mezzo di una forma fuorviante d’espressione.
«Come si può pensare ciò che non accade? Se penso che il King’s College stia bruciando quando non è così, il fatto del suo bruciare non esiste. E allora come faccio a pensarlo? |(Ts-309,50) Come facciamo a impiccare un ladro che non esiste?» La nostra risposta potrebbe assumere la forma seguente: «Quando non esiste, non lo posso impiccare, ma quando non esiste, lo posso cercare».
Qui siamo fuorviati dai sostantivi «oggetto del pensiero» e «fatto» e dai diversi significati della parola «esiste».
Parlare del fatto come di un «complesso di oggetti» sorge da questa confusione (cfr. Tractatus Logico-Philosophicus). Supponiamo di chiedere: «Come si fa a immaginare ciò che non esiste?». La risposta sembra essere: «Se lo facciamo, immaginiamo combinazioni inesistenti di elementi esistenti». Un centauro non esiste, ma una testa, un torso e delle braccia umani e delle gambe di cavallo invece esistono. «Non possiamo però immaginare un oggetto totalmente diverso da qualunque oggetto esistente?» – Dovremmo allora essere propensi a rispondere: «No; gli elementi, gli individui, devono esistere. Se la rossezza, la rotondità o la dolcezza non esistessero, non potremmo immaginarli».
Ma che cosa intendi con «la rossezza esiste»? Il mio orologio esiste, se non è stato smontato, se non è stato distrutto. Cosa chiameremmo «distruggere la rossezza»? Potremmo naturalmente intendere il fatto di distruggere tutti gli oggetti rossi; ma ciò renderebbe impossibile immaginare un oggetto rosso? Supponiamo che qualcuno ci risponda: «Certamente però degli oggetti rossi devono essere esistiti e tu devi averli visti…». – Ma come fai a saperlo? Supponi che ti dica: «Una pressione esercitata sul bulbo oculare produce un’immagine rossa». Non potrebbe essere stato così che hai conosciuto il rosso per la prima volta? E perché invece non avrebbe potuto trattarsi soltanto di una chiazza rossa nella tua immaginazione? (Della difficoltà che avverti |(Ts-309,51) qui bisognerà discutere in seguito.)
Saremmo ora propensi a dire: «Poiché il fatto che, se esistesse, renderebbe vero il nostro pensiero non sempre esiste, non è il fatto che pensiamo». Ma ciò dipende solo da come desidero impiegare la parola «fatto». Perché non dovrei dire: «Credo il fatto che il college sta bruciando»? È solo un’espressione goffa per dire: «Credo che il college stia bruciando». Dire «non è il fatto che crediamo» è già di per sé il risultato di una confusione. Pensiamo di stare dicendo qualcosa come: «Non è la canna da zucchero che mangiamo, è lo zucchero»; «Non è Mr Smith quello appeso nella galleria, bensì il suo ritratto».
Il passo successivo che siamo portati a compiere è pensare che, poiché l’oggetto del nostro pensiero non è un fatto, allora è l’ombra di un fatto. Ci sono vari nomi per quest’ombra, per esempio «proposizione», «senso della frase».
Ciò però non rimuove la difficoltà. Perché ora la domanda è: «Come può qualcosa essere l’ombra di un fatto che non esiste?».
Posso esprimere il problema in una forma diversa dicendo: «Come possiamo sapere di che cosa un’ombra è l’ombra?». – L’ombra sarebbe una specie di ritratto; dunque posso riformulare l’interrogativo dicendo: «Che cosa rende un ritratto un ritratto di Mr N?». La risposta che potrebbe suggerircisi per prima è: «La somiglianza tra il ritratto e Mr N». Tale risposta in effetti mostra ciò che avevamo in mente quando abbiamo parlato |(Ts-309,52) dell’ombra di un fatto. È piuttosto chiaro, tuttavia, che la somiglianza non costituisce la nostra idea di un ritratto; poiché nell’essenza di quest’idea c’è il fatto che debba aver senso parlare di un buon ritratto o di un cattivo ritratto. In altri termini, è essenziale che l’ombra debba essere in grado di rappresentare le cose come in realtà non sono.
Una risposta ovvia e giusta alla domanda «che cosa rende il ritratto il ritratto del tal dei tali?» è che è l’intenzione. Ma se desideriamo sapere che cosa significa «avere l’intenzione che questo sia un ritratto del tal dei tali», vediamo che cosa succede effettivamente quando abbiamo quest’intenzione. Ricorda l’occasione in cui abbiamo parlato di cosa accade quando ci aspettiamo l’arrivo di qualcuno tra le quattro e le quattro e mezza. Avere l’intenzione che un quadro sia un ritratto del tal dei tali (da parte del pittore, per esempio) non è né un particolare stato della mente né un particolare processo mentale. Ci sono però moltissime combinazioni di azioni e stati mentali che dovremmo chiamare «avere l’intenzione che…». Potrebbe trattarsi del fatto che gli hanno detto di dipingere un ritratto di N e lui si è seduto davanti a N e ha svolto certe azioni che chiamiamo «copiare la faccia di N». A ciò si potrebbe obiettare dicendo che l’essenza del copiare è l’intenzione di copiare. Ribatterei che ci sono moltissimi processi diversi che chiamiamo «copiare qualcosa». Facciamo un esempio. Disegno un’ellisse su un foglio e ti chiedo di copiarla. Che cosa caratterizza il processo di copiare? Perché è chiaro che non è il |(Ts-309,53) fatto che tu disegni un’ellisse simile. Avresti potuto cercare di copiarla e non riuscirci; oppure avresti potuto disegnare un’ellisse con un’intenzione completamente diversa e avrebbe potuto essere un caso che sia venuta fuori come quella che avresti dovuto copiare. Quindi che cosa fai quando cerchi di copiare un’ellisse? Be’, la guardi, disegni qualcosa su un pezzo di carta, magari misuri ciò che hai disegnato, magari imprechi se scopri che non concorda con il modello o magari dici «adesso copio quest’ellisse» e semplicemente disegni un’ellisse come questa. C’è una varietà infinita di azioni e di parole, che intrattengono una familiarità reciproca, che noi chiamiamo «cercare di copiare».
Supponi che dicessimo: «Il fatto che un’immagine sia il ritratto di un particolare oggetto consiste nel suo essere derivata dall’oggetto in questione in un modo particolare». È facile descrivere ciò che chiameremmo «processi di derivare un’immagine da un oggetto» (grossomodo, processi di proiezione). Ma riscontriamo una strana difficoltà nell’ammettere che qualcuno di questi processi è ciò che chiamiamo «rappresentazione intenzionale». Perché per qualunque processo (attività) noi possiamo descrivere, c’è un modo di reinterpretare tale proiezione. Dunque – si è tentati di dire – un simile processo non può mai essere l’intenzione stessa. Perché potremmo sempre aver inteso il contrario reinterpretando il processo di proiezione. Immagina questo caso: diamo a qualcuno l’ordine di camminare in una certa direzione additando o disegnando una freccia che indica quella direzione. Supponi che disegnare frecce sia il linguaggio in cui generalmente |(Ts-309,54) diamo un tale ordine. Un tale ordine non potrebbe venir interpretato come se significasse che chi lo riceve deve camminare nella direzione opposta a quella della freccia? Ciò ovviamente potrebbe venire fatto aggiungendo alla freccia dei simboli che potremmo chiamare «un’interpretazione». È facile immaginare un caso in cui, poniamo, per ingannare qualcuno, potremmo accordarci affinché un ordine vada eseguito nel senso opposto rispetto a quello normale. Il simbolo che aggiunge l’interpretazione alla nostra freccia originale potrebbe, per esempio, essere un’altra feccia. Ogni volta che interpretiamo un simbolo in un modo o in un altro, l’interpretazione è un nuovo simbolo aggiunto al primo.
Ora potremmo dire che, quando diamo a qualcuno un ordine mostrandogli una freccia, e non lo facciamo «automaticamente», intendiamo sempre la freccia in un modo o nell’altro. E questo processo di intendere, di qualunque tipo sia, può essere rappresentato da un’altra freccia (che indica nella stessa direzione della prima o in quella opposta). In questa raffigurazione che ci siamo fatti di «intendere e dire» è essenziale che immaginiamo i processi di dire e di intendere come se avessero luogo in due sfere diverse.
È allora corretto dire che nessuna freccia potrebbe essere il significato, poiché ogni freccia potrebbe essere intesa in senso opposto? – Supponi che scriviamo lo schema di dire e di intendere con una colonna di frecce una sotto l’altra.
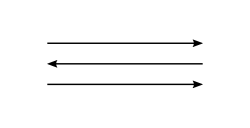
|(Ts-309,55) Se allora questo schema deve servire in qualche modo al nostro scopo, bisogna che ci mostri quale dei tre livelli è il livello del significato. Posso, per esempio, fare uno schema a tre livelli, dove quello più basso è sempre il livello del significato. Adotta pure qualunque modello o schema ti aggradi, esso avrà comunque un livello più basso, riguardo al quale non potrà esserci nulla di simile a un’interpretazione. Dire in questo caso che ogni freccia può ancora essere interpretata significherebbe soltanto che potrei sempre costruire un modello diverso di dire e di intendere che contenesse un livello in più rispetto a quello di cui mi sto servendo.
Mettiamola in questo modo: – ciò che si vuole dire è: «Ogni segno è passibile d’interpretazione; ma il significato non può essere passibile d’interpretazione. È l’ultima interpretazione». Ora presumo che tu consideri il significato un processo che accompagna il dire e che sia traducibile in, e in tal misura equivalente a, un segno ulteriore. Devi perciò ancora spiegarmi quale ritieni sia il marchio di distinzione tra un segno e il significato. Se lo fai, per esempio, dicendo che il significato è la freccia che immagini – in quanto contrapposta a qualunque altra freccia che tu possa disegnare o produrre in qualsiasi altra maniera – così facendo affermi che non considererai alcuna freccia ulteriore un’interpretazione di quella che hai immaginato.
Tutto ciò diverrà più chiaro se prendiamo in considerazione ciò che realmente accade quando diciamo una cosa e intendiamo ciò che diciamo. – Chiediamoci: se diciamo a qualcuno «sarei felicissimo di vederti» e lo intendiamo, accanto a queste parole si svolge un processo cosciente, un processo che in sé potrebbe essere |(Ts-309,56) tradotto in parole dette ad alta voce? Ciò non avverrà praticamente mai.
Immaginiamo però un esempio in cui accade proprio questo. Poniamo che io abbia l’abitudine di accompagnare ogni frase inglese che pronuncio ad alta voce con una frase tedesca detta silenziosamente a me stesso. Se allora, per una ragione o per l’altra, tu chiami la frase silenziosa il significato di quella detta ad alta voce, il processo di intendere che accompagna il processo di parlare sarebbe tale da poter esso stesso venir tradotto in segni esterni. Oppure, prima di ogni frase che diciamo ad alta voce ne diciamo il significato (qualunque esso possa essere) a noi stessi in una specie di a parte. Un esempio perlomeno simile al caso che vogliamo discutere sarebbe dire una cosa e al contempo vedere nell’occhio della mente un’immagine che è il significato e concorda o non concorda con ciò che diciamo. Tali casi e casi simili esistono, ma non sono affatto ciò che accade di regola quando diciamo qualcosa e lo intendiamo, oppure intendiamo qualcos’altro. Ci sono naturalmente casi reali in cui ciò che chiamiamo significato è un processo cosciente definito che accompagna, precede o segue l’espressione verbale ed è esso stesso una specie di espressione verbale o risulta traducibile in un’espressione verbale. Un tipico esempio di ciò è l’«a parte» sul palcoscenico.
Ma ciò che ci induce nella tentazione di pensare al significato di ciò che diciamo come a un processo essenzialmente del tipo di quello che abbiamo descritto è l’analogia tra le forme di espressione:
«dire qualcosa»
«intendere qualcosa»,
|(Ts-309,57) che sembrano riferirsi a due processi paralleli.
Un processo che accompagna le nostre parole e che si potrebbe chiamare «il processo di intenderle» è la modulazione della voce con cui pronunciamo le parole; o uno dei processi simili a questo, quale il gioco della mimica facciale. Questi processi accompagnano le parole dette ad alta voce non nel modo in cui una frase tedesca potrebbe accompagnare una frase inglese o nel modo in cui lo scrivere una frase potrebbe accompagnare il pronunciare una frase; ma nel senso in cui la melodia di una canzone accompagna le parole. Questa melodia corrisponde al «sentimento» con cui diciamo la frase. E desidero precisare che tale sentimento è l’espressione con cui la frase è detta, o qualcosa di simile a quest’espressione.
Torniamo alla domanda: «Che cos’è l’oggetto di un pensiero?» (per esempio, quando diciamo «credo che il King’s College stia bruciando»).
Questa domanda, per come la formuliamo, è già l’espressione di varie confusioni. A mostrarcelo è il mero fatto che suona quasi come una domanda della fisica; come se chiedessi: «Quali sono i costituenti ultimi della materia?» (È una domanda tipicamente metafisica; la caratteristica di una domanda metafisica è che esprimiamo un’assenza di chiarezza riguardo alla grammatica delle parole nella forma di una domanda scientifica.)
Una delle origini della nostra domanda è l’uso duplice della funzione proposizionale «penso X». Diciamo «penso che accadrà questo e questo», oppure «avviene questo e questo», e anche «penso la stessa cosa che pensa lui»; e diciamo «lo sto |(Ts-309,58) aspettando» e anche «mi aspetto che arrivi». Confronta «lo sto aspettando» con «gli sparo». Se lui non c’è, non gli posso sparare. È così che sorge la domanda: «Come possiamo aspettarci qualcosa che non avviene?», «Come facciamo ad aspettarci un fatto che non esiste?».
La via d’uscita da questa difficoltà sembra essere: ciò che ci aspettiamo non è il fatto, ma un’ombra del fatto; per così dire, la cosa più vicina al fatto. Abbiamo detto che ciò non fa che respingere la domanda un passo più indietro. Ci sono varie origini di quest’idea di un’ombra, tra cui questa: diciamo «di sicuro due frasi di lingue diverse possono avere lo stesso senso»; e argomentiamo «quindi il senso non è la stessa cosa della frase», e poi chiediamo «che cos’è il senso?». E facciamo di «esso» un’entità umbratile, una delle molte che creiamo quando vogliamo dare significato a sostantivi a cui non corrisponde alcun oggetto materiale.
Un’altra fonte dell’idea secondo cui l’oggetto del nostro pensiero sarebbe un’ombra è questa: immaginiamo che l’ombra sia un’immagine la cui intenzione non può venire messa in questione, ossia un’immagine che non interpretiamo per comprenderla, ma che comprendiamo senza interpretare. Ci sono immagini di cui dovremmo dire che le interpretiamo, cioè che per comprenderle le traduciamo in un diverso tipo d’immagini; e immagini di cui dovremmo dire che le capiamo immediatamente, senza alcun’interpretazione ulteriore. Se vedi un telegramma scritto in codice e conosci la chiave di tale |(Ts-309,59) codice, in genere non dirai che comprendi il telegramma prima di averlo tradotto nel linguaggio ordinario. Naturalmente avrai soltanto sostituito un tipo di simboli con un altro; ma, se adesso leggi il telegramma nel tuo linguaggio, non avrà luogo alcun processo ulteriore d’interpretazione. – O meglio, ora puoi, in certi casi, tradurre di nuovo il telegramma, per esempio in un’immagine; ma anche in questo caso non farai che sostituire un insieme di simboli con un altro.
L’ombra, per come la pensiamo, è un qualche tipo d’immagine; infatti, ciò che intendiamo con essa è qualcosa di molto simile a un’immagine che si presenta davanti all’occhio della mente; e ciò a sua volta è qualcosa di non dissimile da una rappresentazione pittorica nel senso ordinario. Una fonte dell’idea dell’ombra è sicuramente il fatto che, in certi casi, dire, sentire o leggere una frase porta delle immagini davanti al nostro occhio della mente, immagini che in maniera più o meno stringente corrispondono alla frase e che sono dunque, in un certo senso, traduzioni della frase in un linguaggio pittorico. – Ma è assolutamente essenziale, per la raffigurazione che immaginiamo essere l’ombra, che si tratti di ciò che chiamerò «una raffigurazione per somiglianza». Con questo, non intendo che sia un’immagine simile a quello che, secondo l’intenzione, dovrebbe rappresentare, ma che sia un’immagine che è corretta solo quando è simile a ciò che rappresenta. Si potrebbe usare, per questo tipo d’immagine, la parola «copia». Approssimando, le copie sono buone immagini quando possono essere facilmente confuse con ciò che rappresentano.
Una proiezione piana di un emisfero |(Ts-309,60) terrestre non è un’immagine per somiglianza o una copia in questo senso. Sarebbe immaginabile che io ritraessi la faccia di una persona proiettandola su un foglio in qualche maniera bizzarra ma correttamente rispetto alla regola adottata per la proiezione, in modo tale che nessuno normalmente chiamerebbe la proiezione «un buon ritratto del tal dei tali», perché non gli assomiglierebbe affatto.
Se teniamo a mente la possibilità di un’immagine che, per quanto corretta, non ha alcuna somiglianza con il suo oggetto, l’interpolazione di un’ombra tra la frase e la realtà perde completamente il suo scopo. Perché adesso la frase in sé può fare la funzione di tale ombra. La frase è semplicemente un’immagine di questo genere, priva della benché minima somiglianza con ciò che rappresenta. Se fossimo dubbiosi circa il modo in cui la frase «il King’s College sta bruciando» possa essere una raffigurazione del King’s College che sta bruciando, dovremmo soltanto chiederci: «Come spiegheremmo cosa significa la frase?». Tale spiegazione potrebbe consistere di definizioni ostensive. Diremmo, per esempio, «questo è il King’s College» (indicando l’edificio), «questo è il fuoco» (indicando il fuoco). È così che colleghiamo le parole con le cose.
L’idea che ciò desideriamo che accada debba essere presente come un’ombra nel nostro desiderio è profondamente radicata nelle nostre forme di espressione. In effetti, però, potremmo dire che è soltanto la seconda miglior assurdità rispetto a quella che dovremmo vorremmo dire. Se non fosse troppo assurdo, dovremmo dire che il fatto che desideriamo dev’essere presente nel nostro desiderio. Come possiamo infatti desiderare che proprio questo accada se proprio questo non è presente nel nostro desiderio? |(Ts-309,61) È proprio vero: la mera ombra non basta; perché si ferma prima dell’oggetto; noi vogliamo che il desiderio contenga l’oggetto stesso. – Vogliamo che il desiderio che Mr Smith venga in questa stanza desideri che solo Mr Smith, non un sostituto, compia la venuta, non un sostituto di questa, nella mia stanza, non in un sostituto di questa. Ma questo però è proprio ciò che abbiamo detto.
Potremmo descrivere la nostra confusione così: in perfetto accordo con la nostra forma abituale di espressione pensiamo al fatto che desideriamo accada come a una cosa che non è ancora qui e che, perciò, non posso indicare. Per comprendere la grammatica della nostra espressione «oggetto del nostro desiderio» consideriamo semplicemente la risposta che diamo alla domanda: «Qual è l’oggetto del tuo desiderio?». La risposta a questa domanda naturalmente è «desidero che accada questo e questo». Ma quale sarebbe la risposta se poi chiedessimo: «E qual è l’oggetto di questo desiderio?»? Potrebbe solo consistere in una ripetizione della nostra precedente espressione del desiderio, oppure in una traduzione in qualche altra forma d’espressione. Potremmo, per esempio, indicare ciò che desideravamo con altre parole o illustrarlo con un’immagine, ecc., ecc. Ora, quando abbiamo l’impressione che ciò che chiamiamo l’oggetto del nostro desiderio sia, per così dire, un uomo che non è ancora entrato nella nostra stanza e dunque non può ancora essere visto, immaginiamo che qualunque spiegazione di ciò che desideriamo sia soltanto la migliore alternativa alla spiegazione che ci mostrerebbe il fatto reale, – che, temiamo, non può ancora essere |(Ts-309,62) mostrato poiché non è ancora entrato. – È come se dicessi a qualcuno «mi aspetto che arrivi Mr Smith» e lui mi chiedesse «chi è Mr Smith?» e io rispondessi: «Non te lo posso mostrare ora, poiché non è ancora qui. Posso solo mostrarti una sua immagine». Sembra quasi che io non possa spiegare interamente che cosa ho desiderato fino a quando ciò non è effettivamente accaduto. Naturalmente, però, non è così. In verità non è necessario che, dopo che il desiderio si è realizzato, io sia in grado di fornire una spiegazione migliore di ciò che ho desiderato rispetto a prima; perché è perfettamente possibile che io abbia mostrato Mr Smith al mio amico, e che gli abbia mostrato cosa significa «venire», e che gli abbia mostrato che cos’è la mia stanza, prima dell’arrivo nella mia stanza di Mr Smith.
La nostra difficoltà può essere posta così: pensiamo a cose, – ma come fanno queste cose a entrare nei nostri pensieri? Pensiamo a Mr Smith; ma Mr Smith non deve per forza essere presente. Una sua immagine non basta; come facciamo infatti a sapere chi rappresenta? In realtà, nessun suo sostituto basterà. Allora come può lui stesso essere un oggetto dei nostri pensieri? (Qui mi servo dell’espressione «oggetto del nostro pensiero» in un modo diverso da prima. Intendo una cosa a cui sto pensando, non «ciò che sto pensando».)
Abbiamo detto che la connessione tra il nostro pensare o parlare di un uomo e l’uomo stesso è stata istituita quando, per spiegare il significato della locuzione «Mr Smith», abbiamo indicato costui, dicendo «questo è Mr Smith». Non c’è nulla di misterioso in questa connessione. Ossia, non c’è alcun atto mentale bizzarro che in qualche modo ha evocato Mr Smith nelle nostre menti quando in realtà |(Ts-309,63) lui non c’è. Ciò che rende difficile vedere che la connessione è questa è una strana forma di espressione del linguaggio ordinario, la quale fa sembrare che la connessione tra il nostro pensiero (o l’espressione del nostro pensiero) e la cosa a cui pensiamo debba essere sussistita durante l’atto del pensare.
«Non è bizzarro che in Europa si dovrebbe essere in grado di intendere qualcuno che si trova in America?» – Se qualcuno ci avesse detto «Napoleone venne incoronato nel 1804» e noi gli chiedessimo «intendevi colui che ha vinto la battaglia di Austerlitz?», lui poi potrebbe dire «sì, intendevo lui». L’uso del tempo passato «intendevo» potrebbe dare l’impressione che, quando l’interlocutore ha detto che Napoleone venne incoronato nel 1804, l’idea di Napoleone in quanto vincitore della battaglia di Austerlitz dovesse essere presente nella sua mente.
Qualcuno dice «Mr N verrà a trovarmi oggi pomeriggio»; io chiedo «intendi lui?» indicando qualcuno di presente, e lui risponde «sì». In questa conversazione è stata istituita una connessione tra la locuzione «Mr N» e Mr N. Ma siamo tentati di pensare che, mentre l’amico diceva «Mr N verrà a trovarmi» e intendeva ciò che diceva, la sua mente deve aver istituito la connessione.
Questo è in parte ciò che ci fa pensare all’intendere o al pensare come a una strana attività mentale; dove la parola «mentale» indica che non dobbiamo aspettarci di comprendere come funzionano queste cose.
Ciò che abbiamo detto riguardo al pensare può applicarsi anche all’immaginare. Qualcuno dice di immaginare che il King’s College stia bruciando. Gli chiediamo: «Come fai a sapere che è il King’s College che immagini stia bruciando? Non potrebbe essere un edificio diverso, ma molto simile? In |(Ts-309,64) fondo, la tua immaginazione è davvero talmente esatta da escludere che vi sia una decina di edifici di cui la tua immagine potrebbe essere la rappresentazione?» – Tu però dici: «Non ci sono dubbi che immagino il King’s College e non un altro edificio». Ma non potrebbe essere proprio il dire così a creare la connessione che vogliamo? Dire così infatti è come scrivere le parole «Ritratto di tal dei tali» sotto un dipinto. Avrebbe potuto essere che, mentre immaginavi che il King’s College stesse bruciando, tu dicessi le parole «il King’s College sta bruciando». Ma in moltissimi casi, mentre hai l’immagine, non pronunci certo mentalmente parole esplicative. E considera che, anche se le pronunci, non compi l’intero tragitto tra la tua immagine e il King’s College, ma giungi solo fino alle parole «King’s College». La connessione tra queste parole e il King’s College, forse, è stata istituita in un’altra occasione.
L’errore che siamo propensi a compiere in tutto il nostro ragionare su tali argomenti è pensare che immagini ed esperienze di ogni genere, che sono in qualche senso strettamente connesse le une alle altre, debbano essere contemporaneamente presenti nella nostra mente. Se cantiamo una melodia che sappiamo a memoria, o recitiamo l’alfabeto, le note e le lettere paiono tenersi assieme; ognuna sembra tirarsi dietro la successiva come se fossero perle dello stesso filo e tirandone fuori una ho tirato fuori quella che la seguiva.
Non c’è dubbio che, vedendo l’immagine di un filo di perline che viene tirato fuori da una scatola attraverso un foro nel coperchio, io direi: «Queste perline prima dovevano tutte essere nella scatola». Ma è facile capire che questo è fare |(Ts-309,65) un’ipotesi. Avrei visto la stessa immagine se le perline avessero gradualmente cominciato a esistere nel foro del coperchio. Trascuriamo facilmente la distinzione tra affermare un evento mentale conscio e fare un’ipotesi su ciò che si potrebbe chiamare il meccanismo della mente. A maggior ragione perché tali ipotesi o raffigurazioni del funzionamento della nostra mente sono incorporate in molte forme d’espressione del nostro linguaggio ordinario. Il tempo passato «intendevo» nella frase «intendevo colui che ha vinto la battaglia di Austerlitz» è soltanto una parte di una tale raffigurazione, essendo la mente concepita come un luogo in cui ciò che ricordiamo è custodito, immagazzinato, prima che noi lo esprimiamo. Se fischietto una melodia che conosco bene e vengo interrotto a metà, e se poi qualcuno mi chiede «sapevi come continuare?», io dovrei rispondere «sì, lo sapevo». Che genere di processo è questo sapere come continuare? Parrebbe che, mentre sapevo come continuare, l’intero prosieguo della melodia dovesse essere presente.
Poniti una domanda come: «Quanto ci si mette a sapere come proseguire?». Oppure si tratta di un processo istantaneo? Non stiamo commettendo un errore simile al confondere l’esistenza del disco registrato di una melodia con l’esistenza della melodia? Non stiamo presupponendo che, quando una melodia viene a esistere, debba sempre esserci una specie di disco registrato da cui essa è suonata?
Considera l’esempio seguente: in mia presenza si fa sparare una pistola e io dico: «Questo boato non è stato forte come me |(Ts-309,66) l’aspettavo». Qualcuno mi chiede: «Come è possibile? C’è stato un boato, più forte di quello della pistola, nella tua immaginazione?». Devo confessare che non c’è stato nulla di simile. Lui allora mi dice: «Quindi non ti aspettavi davvero un boato più forte, – bensì forse la sua ombra. – E come facevi a sapere che era l’ombra di un boato più forte?». – Vediamo che cosa, in un tale caso, potrebbe essere realmente accaduto. Magari attendendo lo scoppio ho aperto la bocca, ho afferrato qualcosa per sorreggermi e magari ho detto: «Sarà tremendo». Poi, quando la detonazione è cessata: «Dopo tutto, non è stato così forte». – Certe tensioni nel mio corpo si allentano. Ma qual è la connessione tra queste tensioni, il fatto di aprire la bocca, ecc., e un vero boato più forte? Magari questa connessione è stata istituita dal fatto di aver sentito un tale boato e di aver avuto l’esperienza citata.
Esamina espressioni quali: «avere in mente un’idea», «analizzare l’idea che si ha nella mente». Per non lasciarti fuorviare da esse, osserva ciò che accade realmente quando, per esempio, scrivendo una lettera cerchi le parole che esprimono correttamente l’idea che hai «nella mente». Dire che cerchiamo di esprimere l’idea che abbiamo nella nostra mente è utilizzare una metafora, una metafora che ci si suggerisce naturalmente da sola; e che va bene finché non ci fuorvia mentre facciamo filosofia. Perché, quando rammentiamo ciò che accade realmente in tali casi, troviamo una gran varietà di processi più o meno simili l’uno all’altro. – Potremmo essere portati a dire che in tutte queste situazioni, in ogni caso, siamo guidati da qualcosa nella nostra mente. |(Ts-309,67) Tuttavia, le parole «guidato» e «cosa nella nostra mente» sono impiegate in tanti sensi quanti quelli in cui sono impiegate le parole «idea» ed «espressione di un’idea».
La locuzione «esprimere un’idea che è nella nostra mente» suggerisce che ciò che stiamo cercando di esprimere a parole sia già espresso, soltanto in un diverso linguaggio; che questa espressione è davanti all’occhio della nostra mente; e che quel che facciamo è tradurre dal linguaggio mentale nel linguaggio verbale. Nella maggioranza dei casi che chiamiamo «esprimere un’idea, ecc.» però succede qualcosa di molto diverso. Immagina che cosa succede in casi come questo: sto cercando una parola. Mi si suggeriscono varie parole e io le rifiuto. Alla fine, se ne propone una e dico: «Ecco cosa intendevo!».
(Saremmo propensi a dire che la prova dell’impossibilità di trisecare l’angolo con riga e compasso analizza la nostra idea della trisezione di un angolo. Ma la dimostrazione ci dà una nuova idea di trisezione, di cui prima della costruzione della dimostrazione eravamo sprovvisti. La dimostrazione ci ha condotto lungo una strada che eravamo portati a prendere; ma ci ha condotti lontano da dove eravamo e non ci ha soltanto mostrato chiaramente il luogo in cui eravamo rimasti tutto il tempo.)
Ritorniamo al punto in cui abbiamo detto che non abbiamo guadagnato nulla presupponendo che un’ombra debba intervenire tra l’espressione del nostro pensiero e la realtà di cui il nostro pensiero si interessa. Abbiamo detto che, se volevamo un’immagine della realtà, la frase in sé costituisce già una tale immagine (non, però, |(Ts-309,68) «una raffigurazione per somiglianza»).
Finora ho cercato di rimuovere la tentazione di pensare che «debba esserci» ciò che si chiama un processo mentale del pensare, sperare, desiderare, credere, ecc. indipendente dal processo dell’esprimere un pensiero, una speranza, un desiderio, ecc. Voglio darti la seguente regola pratica: se provi sconcerto riguardo alla natura del pensiero, della credenza, della conoscenza e simili, rimpiazza il pensiero con l’espressione del pensiero, ecc. La difficoltà che risiede in questa sostituzione, e al contempo l’intero suo scopo, è qui: l’espressione della credenza, del pensiero, ecc. è solo una frase; – e la frase ha senso solo in quanto membro di un sistema di linguaggio; come un’espressione all’interno di un calcolo. Ora siamo tentati d’immaginare questo calcolo, per così dire, come uno sfondo permanente dietro ogni frase che diciamo, e di pensare che, anche se la frase per com’è scritta su un foglio o pronunciata è isolata, nell’atto mentale del pensare invece il calcolo è presente – tutto nel suo insieme. L’atto mentale sembra fare in una maniera miracolosa ciò che non potrebbe essere fatto da alcun atto di manipolazione di simboli. Quando la tentazione di pensare che in un certo senso l’intero calcolo dev’essere presente contemporaneamente svanisce, non c’è più bisogno di postulare l’esistenza di uno strano tipo di atto mentale che affianchi la nostra espressione. Ciò, naturalmente, non significa che abbiamo mostrato che strani atti di coscienza non accompagnino l’espressione dei nostri pensieri! Solamente non diciamo più che devono per forza accompagnarli. |(Ts-309,69)
«Ma l’espressione dei nostri pensieri può sempre mentire, perché possiamo dire una cosa e intenderne un’altra.» Immagina le molte cose diverse che accadono quando diciamo una cosa e ne intendiamo un’altra! – Fa’ il seguente esperimento: pronuncia la frase «fa caldo in questa stanza» e intendi «fa freddo». Osserva attentamente ciò che stai facendo.
Potremmo facilmente immaginare esseri che svolgono l’atto di pensare in privato tramite «a parte» e che, per mentire, dicono una cosa ad alta voce e poi fanno un a parte in cui affermano il contrario.
«Ma intendere, pensare, ecc. sono esperienze private. Non sono attività come scrivere, parlare, ecc.» – Perché però non dovrebbero consistere nelle specifiche esperienze private dello scrivere – le sensazioni muscolari, visive, tattili dello scrivere o del parlare?
Fa’ il seguente esperimento: di’ e intendi una frase, per esempio – «probabilmente domani pioverà». Ora pensa di nuovo lo stesso pensiero, intendi ciò che hai appena inteso, ma senza dire nulla (né ad alta voce né a te stesso). Se il pensare che domani pioverà ha accompagnato il dire che domani pioverà, allora compi solo la prima attività e rinuncia alla seconda. – Se pensare e parlare stessero nella relazione che c’è tra le parole e la melodia di una canzone, potremmo rinunciare a parlare e pensare e basta, proprio come possiamo cantare la melodia senza le parole.
Ma non si può, in ogni caso, parlare e basta, rinunciando a pensare? |(Ts-309,70) Certamente, – ma osserva che genere di cosa stai facendo se parli senza pensare. Osserva innanzitutto che a distinguere il processo che potremmo chiamare «parlare e intendere ciò che si dice» da quello di parlare senza pensare non è necessariamente ciò che accade mentre tu parli. Ciò che distingue le due cose potrebbe benissimo essere ciò che accade prima o dopo che tu parli.
Supponi che io provi, deliberatamente, a parlare senza pensare; – concretamente, che cosa farei? Potrei leggere una frase da un libro, cercare di leggerla automaticamente, ossia tentando di impedirmi di seguire la frase con le immagini e sensazioni che altrimenti essa produrrebbe. Un modo di farlo consisterebbe nel concentrare l’attenzione su qualcos’altro mentre pronuncio la frase, per esempio dandomi un bel pizzicotto mentre la pronuncio. – Mettiamola così: pronunciare una frase senza pensare consiste nell’accendere l’eloquio e nello spegnere certi accompagnamenti dell’eloquio. Ora chiediti: pensare la frase senza pronunciarla consiste nel girare l’interruttore (accendendo ciò che prima abbiamo spento e viceversa)? Ossia: pensare la frase senza pronunciarla consiste semplicemente nel tenere acceso ciò che accompagnava le parole ma rinunciando alle parole? Prova a pensare i pensieri di una frase senza la frase e vedi se è questo ciò che accade.
Tiriamo le somme: se vagliamo gli utilizzi che facciamo di parole quali «pensare», «intendere», «desiderare», ecc., |(Ts-309,71) lo svolgimento di un tale processo ci sbarazza della tentazione di cercare un atto caratteristico del pensare, indipendente dall’atto di esprimere i nostri pensieri e clandestinamente riposto in qualche strano mezzo. Le forme stabilite di espressione non ci impediscono più di riconoscere che l’esperienza di pensare può essere solo l’esperienza di dire, o può consistere di quest’esperienza più altre che l’accompagnano. (È utile anche esaminare il caso seguente: supponi che una moltiplicazione faccia parte di una frase; chiediti che cosa comporti il dire la moltiplicazione «7 × 5 = 35» pensandola e, invece, il dirla senza pensarla.) Il vaglio della grammatica di una parola indebolisce la posizione di certi standard della nostra espressione che ci impedivano di vedere i fatti con una prospettiva imparziale. Le nostre ricerche hanno tentato di rimuovere tale parzialità, che ci costringe a pensare che i fatti debbano conformarsi a certe immagini incorporate nel nostro linguaggio.
«Intendere» è una delle parole di cui si può dire che svolgono uno strano lavoro nel nostro linguaggio. Sono queste parole a causare buona parte dei grattacapi filosofici. Immagina un’istituzione in cui la maggioranza dei membri esercita certe funzioni regolari, funzioni che possono essere facilmente descritte, poniamo, negli statuti dell’istituzione. Ci sono, tuttavia, alcuni membri a cui vengono assegnati lavori strani, che possono comunque essere di grande importanza. – Ciò che causa la maggior parte degli inciampi filosofici è il fatto che siamo tentati di descrivere l’uso di importanti parole dai «lavori strani» come se fossero parole con funzioni normali. |(Ts-309,72)
La ragione per cui non ho parlato subito di esperienze personali è che pensare a questo argomento solleva una serie di difficoltà filosofiche che minacciano di mandare in pezzi tutte le nostre nozioni di senso comune riguardo a ciò che comunemente chiamiamo gli oggetti della nostra esperienza. Venendo colpiti da questi problemi avremmo l’impressione che tutto quello che abbiamo detto sui segni e sui vari oggetti che abbiamo menzionato nei nostri esempi debba rientrare in questo calderone.
Per descrivere tale situazione, in un certo senso tipica dello studio della filosofia, talvolta si è detto che nessun problema filosofico può essere risolto fino a quando non sono risolti tutti i problemi filosofici; ciò significa che fino a quando non sono risolti tutti, ogni nuova difficoltà rende passibili di dubbio tutti i risultati precedentemente conseguiti. Parlando in termini così generali, a una simile affermazione si può rispondere solo in maniera approssimativa: cioè dicendo che ogni nuovo problema può mettere in dubbio la posizione che i risultati parziali dovrebbero occupare nel quadro finale. Poi si parlerà di dover reinterpretare tali risultati; io risponderei: devono essere posti in un diverso ambiente.
Immagina che dobbiamo mettere in ordine i libri di una biblioteca. Quando cominciamo, i libri giacciono alla rinfusa sul pavimento. Ci sarebbero molti modi di ordinarli e metterli al loro posto. Si potrebbero prendere i libri uno per uno e metterli uno alla volta al posto giusto sullo scaffale. Oppure |(Ts-309,73) potremmo raccogliere vari libri dal pavimento e metterli in fila su uno scaffale, soltanto per indicare che dovrebbero stare assieme in quell’ordine. Man mano che mettiamo in ordine la biblioteca, questa fila di libri dovrà tutta intera essere spostata altrove. Sarebbe però sbagliato dire che metterli assieme su uno scaffale, allora, non era compiere un passo verso il risultato finale. In questo caso, infatti, è piuttosto ovvio che aver messo assieme dei libri che dovevano stare assieme è stato un evidente successo, anche se l’intera fila ha poi dovuto essere spostata. Alcuni dei maggiori successi della filosofia però potrebbero essere paragonati soltanto all’atto di prendere alcuni libri che sembravano dover stare assieme e di disporli tutti su scaffali diversi; senza che nulla risulti definitivo circa la loro posizione tranne il fatto che non stanno più l’uno accanto all’altro. L’osservatore che non conosce la difficoltà del compito, in tal caso, potrebbe ben pensare che non sia stato conseguito alcun successo. – La difficoltà in filosofia consiste nel non dire più di quanto si sa. Per esempio, nel vedere che quando abbiamo messo due libri assieme nel loro giusto ordine non li abbiamo perciò disposti nelle loro posizioni definitive.
Quando pensiamo alla relazione degli oggetti che ci circondano con l’esperienza personale che noi ne facciamo, talvolta siamo tentati di dire che queste esperienze personali sono il materiale di cui è fatta la realtà. Come sorge tale tentazione diventerà chiaro in seguito.
Quando pensiamo così, abbiamo l’impressione di perdere la nostra salda presa sugli oggetti che ci circondano. E invece ci rimangono |(Ts-309,74) molte esperienze personali separate di individui. Queste esperienze personali, di nuovo, sembrano vaghe e in costante flusso. Il nostro linguaggio non pare essere stato concepito per descriverle. Siamo tentati di pensare che, per poter chiarire tali questioni filosoficamente, il linguaggio ordinario è troppo rozzo, che ci serve un linguaggio più sottile.
Ci pare di aver fatto una scoperta – che potrei descrivere dicendo che il terreno su cui stavamo e che sembrava solido e affidabile si è rivelato acquitrinoso e malsicuro. – Cioè, questo accade quando filosofiamo; perché non appena torniamo al punto di vista del senso comune una simile incertezza generale scompare.
Questa bizzarra situazione può essere in parte chiarita con un esempio; anzi, con una specie di parabola che illustra la difficoltà in cui ci troviamo e che mostra inoltre la via di uscita da difficoltà di questo genere: i divulgatori scientifici ci hanno detto che il pavimento su cui camminiamo non è solido, come appare al senso comune, poiché si è scoperto che il legno consiste di uno spazio riempito da particelle tanto rade che potremmo quasi considerarlo vuoto. Ciò potrebbe sconcertarci, perché naturalmente in un certo senso sappiamo che il pavimento è solido o che, se non lo è, questo potrebbe dipendere dalla sua eventuale marcescenza, ma non dal fatto che è composto di elettroni. Affermare, per quest’ultimo motivo, che il pavimento non è solido è usare il linguaggio in modo improprio. Perché anche se le particelle fossero grandi come granelli di sabbia e vicine l’una all’altra come i granelli tra loro in un mucchio di sabbia, il |(Ts-309,75) pavimento non sarebbe comunque solido se fosse composto da tali particelle nel modo in cui un mucchio di sabbia è fatto di granelli. La nostra perplessità era fondata su un malinteso; l’immagine dello spazio pressoché vuoto era stata applicata a sproposito. Poiché tale immagine della struttura della materia era intesa a spiegare proprio il fenomeno della sua solidità.
Come in quest’esempio la parola «solidità» è stata utilizzata a sproposito e sembrava che avessimo mostrato che nulla era realmente solido, ugualmente, nell’affermare le nostre perplessità riguardo alla vaghezza generale dell’esperienza sensoriale e al flusso di tutti i fenomeni, impieghiamo le parole «flusso» e «vaghezza» a sproposito, in maniera tipicamente metafisica, ossia senza un’antitesi; mentre nell’impiego corretto e quotidiano, la vaghezza si contrappone alla chiarezza, il flusso alla stabilità, l’imprecisione alla precisione, e il problema alla soluzione. Persino la parola «problema», si potrebbe dire, è applicata malamente a proposito dei grattacapi filosofici. Queste difficoltà, fintantoché sembrano problemi, sono stuzzicanti e appaiono insolubili.
Ho la tentazione di dire che solo la mia esperienza è reale: «So che vedo, sento, provo dolore, ecc. ma non che ciò accada a qualcun altro. Questo non posso saperlo, perché io sono io e loro sono loro».
D’altra parte, mi vergogno a dire a qualcuno che la mia esperienza è l’unica reale; e so che l’interlocutore mi risponderà che potrebbe affermare esattamente lo stesso della propria esperienza. Ciò pare condurci a uno sciocco cavillo. Inoltre, |(Ts-309,76) mi si dice: «Se provi compassione per il dolore di un altro, di certo devi perlomeno credere che costui provi dolore». Ma come posso mai credere ciò? Come possono queste parole avere un senso per me? Come potrei anche solo essermi fatto l’idea dell’esperienza di un altro se di essa non è nemmeno possibile alcuna evidenza?
Ma non era questa una domanda bizzarra da porre? Non posso credere che qualcun altro abbia dei dolori? Non è facilissimo crederlo? – È una riposta dire che le cose sono come appaiono al senso comune? – Di nuovo, non c’è bisogno di dirlo, non sentiamo simili difficoltà nella vita ordinaria. Né sarebbe vera l’affermazione che le sentiamo quando analizziamo le nostre esperienze mediante l’introspezione, o quando le investighiamo scientificamente. In qualche modo però, quando osserviamo le nostre esperienze in un certo modo, la nostra espressione tende a ingarbugliarsi. Abbiamo l’impressione di non avere i pezzi giusti per completare il puzzle, o di non averli tutti. Ma ci sono tutti, solo che sono tutti mischiati; e tra il puzzle e il presente caso c’è un’altra analogia: non serve a nulla tentare di far combaciare i pezzi a forza. Tutto ciò che dovremmo fare è guardarli attentamente e sistemarli. |(Ts-309,77)
Ci sono proposizioni di cui possiamo dire che descrivono fatti nel mondo materiale (mondo esterno). Approssimativamente, trattano di oggetti fisici; corpi, fluidi, ecc. Non sto pensando in particolare alle leggi delle scienze naturali, ma a qualunque proposizione come «i tulipani nel nostro giardino sono in piena fioritura», oppure «Smith arriverà da un momento all’altro». D’altro canto, ci sono proposizioni che descrivono esperienze personali, come quando il soggetto in un esperimento psicologico descrive le proprie esperienze sensoriali; per esempio, la sua esperienza visiva, indipendente da quali corpi sono effettivamente davanti ai suoi occhi e, nota bene, indipendente anche da qualunque processo che potrebbe essere osservato in atto nella sua retina, nei suoi nervi, nel suo cervello o in altre parti del suo corpo. (Cioè, indipendente da fatti sia fisici sia fisiologici.)
A prima vista può sembrare (il perché però può chiarirsi solo in seguito) che qui abbiamo due tipi di mondi, mondi fatti di materiali diversi; un mondo mentale e un mondo fisico. Il mondo mentale in effetti può essere immaginato come gassoso o anzi etereo. E qui permettimi ti ricordarti il ruolo bizzarro svolto dal gassoso e dall’etereo in filosofia, – quando percepiamo che un sostantivo non è utilizzato come ciò che in generale chiameremmo il nome di un oggetto, e quando dunque non possiamo fare a meno di dire a noi stessi che è il nome di un oggetto etereo. Cioè, conosciamo già l’idea di «oggetti eterei» in quanto sotterfugio, quando siamo in imbarazzo circa la grammatica di certe parole |(Ts-309,78) e sappiamo soltanto che non sono usate come nomi di oggetti materiali. Questo è un indizio su come il problema dei due materiali, mente e materia, finirà per dissolversi.
Talvolta si ha l’impressione che i fenomeni dell’esperienza personale siano in un certo senso fenomeni che hanno luogo negli strati più alti dell’atmosfera, in contrapposizione ai fenomeni materiali che accadono al livello del suolo. Ci sono prospettive secondo cui tali fenomeni negli strati più alti sorgono quando i fenomeni materiali raggiungono un certo grado di complessità. Per esempio, che i fenomeni mentali, l’esperienza sensoriale, la volizione, ecc. emergono una volta che si è evoluto un tipo di corpo animale di una certa complessità. Pare esserci in questo una qualche verità ovvia, poiché l’ameba certamente non parla né scrive né dibatte, mentre noi sì. D’altro canto, qui sorge il problema che potrebbe esprimersi con la domanda: «È possibile per una macchina pensare?» (sia che l’azione di questa macchina possa essere prevista dalle leggi della fisica oppure, eventualmente, solo da leggi di un altro tipo che valgono per il comportamento degli organismi). Il grattacapo espresso in tale domanda non consiste in realtà nel fatto che non conosciamo ancora una macchina in grado di svolgere un tale compito. La domanda non è analoga a quella che qualcuno avrebbe potuto fare un secolo fa: «Può una macchina liquefare un gas?». Il grattacapo consiste invece nel fatto che la frase «una macchina pensa» (percepisce, desidera) sembra in qualche modo priva di senso. È come se avessimo chiesto: «Il numero 3 ha un colore?». («Che colore potrebbe essere, visto che ovviamente |(Ts-309,79) non ha nessuno dei colori a noi noti?») Perché in un aspetto della questione, l’esperienza personale, lungi dall’essere il prodotto di processi fisici, chimici, fisiologici, pare essere la base stessa di qualunque cosa sensata noi diciamo riguardo a tali processi. Guardando la cosa da questo punto di vista siamo portati a usare la nostra idea di un materiale da costruzione in un’altra maniera fuorviante ancora, e a dire quindi che il mondo intero, mentale e fisico, è fatto di un materiale soltanto.
Quando guardiamo a tutto ciò che sappiamo e possiamo dire sul mondo come fondato sull’esperienza personale, allora ciò che sappiamo sembra perdere buona parte del suo valore, della sua affidabilità e della sua solidità. Siamo allora portati a dire che è tutto «soggettivo»; e «soggettivo» è utilizzato dispregiativamente, come quando diciamo che un’opinione è meramente soggettiva, una questione di gusto. Ora, il fatto che ciò sembri scuotere l’autorità dell’esperienza e della conoscenza indica che qui il nostro linguaggio ci induce nella tentazione di tracciare qualche analogia fuorviante. Ciò dovrebbe rammentarci il caso in cui il divulgatore scientifico sembrava averci mostrato che il pavimento su cui camminiamo non è davvero solido perché fatto di elettroni.
Ci ritroviamo a combattere i problemi causati dal nostro modo di esprimerci.
Un altro di questi grattacapi, strettamente imparentato con il precedente, è espresso nella frase: «Posso sapere solo che io ho esperienze personali, non che ce le ha qualcun altro». – Che qualcun altro abbia esperienze personali andrebbe quindi considerata un’ipotesi non necessaria? – Ma è davvero un’ipotesi? Come faccio a fare |(Ts-309,80) l’ipotesi, se essa trascende ogni possibile esperienza? Come potrebbe tale ipotesi essere garantita dal significato? (Non sarebbe come cartamoneta non garantita dall’oro?) – È inutile che qualcuno ci dica che, anche se non sappiamo se il prossimo prova dolore, certamente lo crediamo quando, per esempio, lo compatiamo. Certamente non lo compatiremmo se non credessimo che prova dolore; ma questa è una credenza filosofica, metafisica: un realista mi compatisce più di un idealista o di un solipsista? – Infatti, il solipsista chiede: «Come possiamo credere che un altro provi dolore? Che cosa significa crederlo? Come può avere senso l’espressione di una simile congettura?». Ora, la risposta del filosofo del senso comune (che, nota bene, non è l’uomo del senso comune, il quale è lontano dal realismo tanto quanto dall’idealismo) è che sicuramente non c’è difficoltà nell’idea del supporre, pensare, immaginare che qualcun altro abbia ciò che ho io. Ma il guaio del realista consiste sempre nel fatto che costui non risolve ma salta le difficoltà scorte dai suoi avversari, che peraltro non riescono a risolverle. La risposta realista, per noi, si limita a far risaltare la difficoltà; perché chi argomenta così trascura la differenza tra diversi utilizzi delle parole «avere», «immaginare». «A ha un dente d’oro» significa che il dente è nella bocca di A. Il caso del mal di denti, che io sostengo di non sentire perché è nella sua bocca, non è analogo al caso del dente |(Ts-309,81) d’oro. A causare il problema è l’analogia apparente, e di nuovo la mancanza di analogia, tra questi due casi. Ed è quest’elemento problematico della nostra grammatica che il realista non vede. È concepibile che io provi dolore al dente nella bocca di un altro uomo; e chi dice di non poter sentire il mal di denti altrui non sta rifiutando questo. Vedremo chiaramente la difficoltà grammaticale in cui ci troviamo soltanto se prenderemo dimestichezza con l’idea di provare dolore nel corpo altrui. Perché altrimenti, riflettendo sconcertati su tale problema, tenderemo a confondere la nostra proposizione metafisica «non posso sentire il suo dolore» con la proposizione empirica «non possiamo avere (non abbiamo di regola) dolori nel dente di un altro». In quest’ultima proposizione il verbo «potere» è utilizzato nello stesso modo in cui lo si impiega nella proposizione «un chiodo di ferro non può graffiare il vetro». (Potremmo riscriverla nella forma «l’esperienza insegna che un chiodo di ferro non graffia il vetro», sbarazzandoci dunque del «potere».) Per vedere che è concepibile che una persona provi dolore nel corpo di un altro, si deve esaminare che genere di fatti consideriamo criteri del fatto che un dolore sia in un certo luogo. È facile immaginare il caso seguente: quando vedo le mie mani non sono sempre consapevole della loro connessione con il resto del corpo. Ossia, spesso vedo la mano muoversi ma non vedo il braccio che la connette al torace. Né è necessario che, in un momento simile, controlli in qualche altro modo l’esistenza del mio braccio. Quindi la mano, per quanto ne so, potrebbe essere connessa al |(Ts-309,82) corpo di un uomo che sta in piedi alle mie spalle (o potrebbe, naturalmente, non essere collegata ad alcun corpo umano). Supponi che io senta un dolore e che sulla base soltanto dell’evidenza di tale dolore, per esempio tenendo gli occhi chiusi, io lo chiami un dolore alla mano sinistra. Qualcuno mi chiede di toccare il punto dolente con la mano destra. Lo faccio, e guardandomi attorno percepisco di stare toccando la mano del mio vicino (ossia la mano connessa al torace del mio vicino).
Fatti questa domanda: come sappiamo dove indicare quando ci chiedono di indicare il punto dolente? Questo genere di indicare può essere paragonato all’indicare un punto nero su un foglio quando qualcuno dice «indica il punto nero sul foglio»? Supponi che ti dicano «tu indichi questo punto perché sai prima di indicarlo che il dolore è lì»; chiediti «che cosa significa sapere che il dolore è lì?» La parola «lì» si riferisce a una località; ma in quale spazio, cioè, una «località» in che senso? Sappiamo qual è il luogo del dolore nello spazio euclideo, in modo tale che quando sappiamo di avere dei dolori sappiamo quanto tali dolori distano da due delle pareti di questa stanza e dal pavimento? Quando ho dolore nella punta del dito e poi con quel dito mi tocco il dente, il mio dolore adesso è sia un mal di denti sia un dolore al dito? Sicuramente in un certo senso si può dire che il dolore sia localizzato nel dente. La ragione per cui in questo caso è sbagliato dire che ho mal di denti è che per essere nel dente il dolore dovrebbe distare un millimetro e mezzo dalla punta del dito? Ricorda che la parola «dove» può riferirsi a località in svariati sensi |(Ts-309,83) diversi. (Con questa parola si giocano molti giochi grammaticali più o meno simili gli uni agli altri. Pensa ai vari usi del numerale «1».) Posso sapere dov’è una cosa e poi indicarla in virtù di tale conoscenza. La conoscenza mi dice dove indicare. Qui abbiamo concepito tale conoscenza come la condizione per indicare volontariamente l’oggetto. Quindi possiamo dire: «Posso indicare il punto che intendi perché lo vedo», «posso darti indicazioni per arrivare quel tale luogo perché so dov’è; prima gira a destra, ecc.». Ora si è propensi a dire «devo sapere dov’è una cosa prima di poterla indicare». Magari saresti meno entusiasta di dire «devo sapere dov’è una cosa prima di poterla guardare». Talvolta naturalmente quest’ultima affermazione è corretta. Ma siamo tentati di pensare che ci sia un particolare stato psichico o evento, la conoscenza del luogo, che deve precedere ogni atto volontario di indicare, muoversi verso, ecc. Pensa al caso analogo: «Si può obbedire a un ordine solo dopo averlo compreso».
Se indico il punto dolente sul mio braccio, in che senso si può dire che sapevo dov’era il dolore prima d’indicare quel punto? Prima d’indicare avrei potuto dire «il dolore è nel mio braccio sinistro». Supponiamo che il mio braccio sia stato ricoperto di un reticolo di linee numerate in modo tale che io possa riferirmi a ogni luogo della sua superficie. Prima di poterlo indicare, avrei dovuto per forza essere in grado di descrivere il punto dolente per mezzo di queste coordinate? Ciò che voglio dire è che l’atto d’indicare determina un luogo del dolore. Questo |(Ts-309,84) atto d’indicare, comunque, non va confuso con quello di trovare, il punto dolente tastando. Le due attività infatti possono portare a esiti diversi.
Può essere pensata un’enorme quantità di casi in cui dovremmo dire che qualcuno ha dolore nel corpo di un’altra persona; o, magari, in un pezzo di arredamento, o in un punto vuoto. Certamente non bisogna dimenticare che un dolore in un punto particolare del nostro corpo, per esempio in un dente superiore, ha un suo peculiare circondario tattile e cinestetico; sollevando la mano di una poca distanza tocchiamo l’occhio; e la locuzione «a poca distanza» qui si riferisce alla distanza tattile o alla distanza cinestetica o a entrambe. (È facile immaginare distanze tattili e cinestetiche correlate in modo diversi dal solito. La distanza tra la nostra bocca e il nostro occhio potrebbe sembrare molto grande «ai muscoli del nostro braccio» quando muoviamo un dito dalla bocca all’occhio. Pensa a quanto immagini che sia grande la carie mentre il dentista ti trapana e ti sonda il dente.)
Quando ho detto che se solleviamo di poco la mano tocchiamo l’occhio, mi riferivo soltanto all’evidenza tattile. Ossia, il criterio per il fatto che il mio dito toccasse l’occhio doveva consistere solo nel fatto che io provassi la sensazione particolare che mi avrebbe fatto dire che mi stavo toccando l’occhio, anche in assenza di evidenze visive e anche se, guardandomi allo specchio, avessi visto il mio dito toccare non l’occhio ma, poniamo, la fronte. Proprio come la «poca distanza» a cui mi riferivo era tattile o cinestetica, così anche i luoghi di cui ho detto che «sono |(Ts-309,85) poco distanti» erano luoghi tattili. Dire che nello spazio tattile o cinestetico il mio dito si muove dal dente all’occhio significa allora che ho le esperienze tattili e cinestetiche che normalmente abbiamo quando diciamo «il mio dito si muove dal dente all’occhio». Ma ciò che consideriamo come evidenza di quest’ultima proposizione non è affatto, come sappiamo tutti, qualcosa di soltanto tattile o cinestetico. Infatti, se avessi le sensazioni tattili o cinestetiche in questione, potrei ancora negare la proposizione «il mio dito si muove… ecc.…» sulla base di ciò che ho visto. Tale proposizione è una proposizione inerente a oggetti fisici. (E ora non pensare che l’espressione «oggetti fisici» sia intesa a distinguere un tipo di oggetto fisico da un altro.) La grammatica delle proposizioni che chiamiamo proposizioni inerenti a oggetti fisici ammette una varietà di evidenze in favore di ogni proposizione di questo tipo. Caratterizza la grammatica della proposizione «il mio dito si muove ecc.» che io considero le proposizioni «lo vedo muoversi», «lo sento muoversi», «lui lo vede muoversi», «lui mi dice che si muove», ecc., come evidenze in suo favore. Ora, se dico «vedo la mia mano muoversi», a prima vista ciò pare presupporre che io concordi con la proposizione «la mia mano si muove». Ma se considero la proposizione «vedo la mia mano muoversi» come una delle evidenze in favore della proposizione «la mia mano si muove», la verità della seconda non è, naturalmente, presupposta nella verità della prima. Si potrebbe quindi suggerire l’espressione «sembra che la mia mano si stia muovendo» al posto di «vedo la mia mano muoversi». Ma tale espressione, |(Ts-309,86) pur indicando che la mia mano potrebbe sembrare in movimento senza davvero esserlo, potrebbe comunque suggerire che dopo tutto, per dare l’impressione che si stia muovendo, dev’esserci una mano; mentre potremmo facilmente immaginare casi in cui la proposizione che descrive l’evidenza visiva è vera e allo stesso tempo altre evidenze ci fanno dire che non ho questa mano. Il nostro modo ordinario di espressione lo occulta. Nel linguaggio ordinario scontiamo l’handicap di dover descrivere, per esempio, una sensazione tattile per mezzo dei termini per oggetti fisici come la parola «occhio», «dito», ecc., quando ciò che vogliamo dire non implica l’esistenza di un occhio o dito ecc.: dobbiamo impiegare una descrizione indiretta delle nostre sensazioni. Questo naturalmente non significa che il nostro linguaggio ordinario è insufficiente per i nostri scopi, ma che è un po’ scomodo e talvolta fuorviante. La ragione di questa peculiarità del nostro linguaggio è naturalmente la regolare coincidenza di certe esperienze sensoriali. Quindi quando sento il mio braccio muoversi, nella maggior parte dei casi lo vedo anche muoversi. E se lo tocco con la mano, anche la mano sente il movimento, ecc. (L’uomo a cui è stato amputato un piede descriverà un particolare dolore come dolore al piede.) In tali casi sentiamo di avere grande necessità di un’espressione come: «Una sensazione si sposta dalla mia guancia tattile al mio occhio tattile». Ho detto tutto questo perché, se sei consapevole dell’ambiente tattile e cinestetico di un dolore, puoi avere difficoltà a immaginare che si potrebbe avere mal di denti in un punto che non siano i propri denti. Ma se |(Ts-309,87) immaginiamo un tale caso, ciò significa semplicemente che immaginiamo una correlazione tra esperienze visive, tattili, cinestetiche, ecc. diversa dalla correlazione ordinaria. Quindi possiamo immaginare una persona che abbia la sensazione del mal di denti più quelle esperienze tattili e cinestetiche che normalmente sono collegate con il vedere la propria mano spostarsi dalla propria bocca al proprio naso, al proprio occhio, ecc., ma correlate all’esperienza visiva della sua mano che si muove verso tali punti sul viso di un’altra persona. Oppure possiamo anche immaginare una persona che abbia la sensazione cinestetica di muovere la propria mano e la sensazione tattile, nelle dita e in faccia, delle proprie dita che si muovono sulla propria faccia, mentre le sensazioni cinestetiche e visive che ha dovrebbero essere descritte come quelle delle sue dita che si muovono sul suo ginocchio. Se avessimo una sensazione di mal di denti più certe sensazioni tattili e cinestetiche che solitamente sono caratteristiche del toccare il dente dolorante e le parti a esso adiacenti del nostro viso, e se queste sensazioni fossero accompagnate dal vedere la mia mano toccare lo spigolo del tavolo e muoversi su di esso, allora saremmo incerti se chiamare quest’esperienza un’esperienza di mal di denti nel tavolo o meno. Se, d’altro canto, le sensazioni tattili e cinestetiche descritte fossero correlate all’esperienza visiva di vedere la mia mano toccare un dente o altre parti del viso di un’altra persona, non c’è dubbio che chiamerei quest’esperienza «mal di denti nel dente di un’altra persona».
Ho detto che l’uomo che sosteneva che fosse impossibile |(Ts-309,88) sentire il dolore del prossimo non desiderava perciò negare che una persona potesse provare dolore nel corpo di un’altra persona. In effetti, costui avrebbe detto: «Posso avere mal di denti nel dente di qualcun altro, ma non il suo mal di denti».
Quindi la proposizione «A ha un dente d’oro» e «A ha mal di denti» non sono impiegate in maniera analoga. Differiscono nella loro grammatica, che a prima vista potrebbe sembrare identica.
Riguardo all’uso della parola «immaginare» – si potrebbe dire: «Di sicuro esiste un atto ben definito d’immaginare che l’altra persona ha dolore». Naturalmente noi non lo neghiamo, né neghiamo alcun’altra affermazione che verta su fatti. Ma vediamo: se ci facciamo un’immagine del dolore di un’altra persona, l’applichiamo nella stessa maniera in cui applichiamo l’immagine, per esempio, di un occhio nero quando immaginiamo che l’altra persona abbia un occhio nero? Sostituiamo di nuovo l’immaginare, nel senso ordinario, col creare una raffigurazione pittorica. (Questo potrebbe benissimo essere il modo in cui certi esseri immaginano.) Poniamo allora che qualcuno immagini in questo modo che A ha un occhio nero. Un’applicazione molto importante di questa raffigurazione consisterà nel confrontarla con l’occhio reale per vedere se la raffigurazione è corretta. Quando immaginiamo vividamente qualcuno che patisce dei dolori, spesso della nostra immagine entra a far parte ciò che potremmo chiamare l’ombra di un dolore avvertito nella località corrispondente a quella in cui diciamo che l’altro sente il suo dolore. Ma il senso in cui un’immagine è un’immagine è determinato dal modo in cui la si confronta con la realtà. Questo potremmo chiamarlo il metodo di proiezione. Ora pensa all’atto di confrontare un’immagine del mal di denti di A con il suo |(Ts-309,89) mal di denti. Come li confronteresti? Se dici che li confronti «indirettamente» tramite il suo comportamento fisico, ti rispondo che ciò significa che non li confronti come confronti la raffigurazione del suo comportamento con il suo comportamento.
Di nuovo, quando dici «ti concedo che non puoi sapere quando A prova dolore, puoi solo congetturarlo» non vedi la difficoltà contenuta nei diversi usi delle espressioni «fare congetture» e «sapere». A che tipo d’impossibilità ti riferivi quando hai detto che non potevi saperlo? Non stavi pensando a un caso analogo a quello in cui non si poteva sapere se l’altra persona avesse un dente d’oro in bocca perché aveva la bocca chiusa? Qui ciò che non sapevi potevi comunque immaginare di saperlo; aveva senso dire che avevi visto il dente anche se non l’avevi visto; o meglio, ha senso dire che non vedi il dente e quindi ha senso anche dire che lo vedi. Quando invece mi hai concesso che un uomo non può sapere se l’altra persona prova dolore, tu non volevi dire che nella realtà dei fatti le persone non lo sapevano, ma che non aveva senso dire che lo sapevano (e quindi neanche dire che non lo sapevano). Se dunque in questo caso usi l’espressione «congetturare» o «credere», non la usi in quanto contrapposta a «sapere». Cioè non hai affermato che sapere era un obiettivo che non sei stato in grado di raggiungere e che devi accontentarti di fare congetture; bensì che non c’è obiettivo in questo gioco. Ugualmente, quando qualcuno dice «non puoi contare |(Ts-309,90) fino in fondo la serie dei numeri cardinali», questo qualcuno non fa un’affermazione inerente alla fragilità umana, ma a una convenzione che abbiamo istituito. La nostra affermazione non è paragonabile, anche se vi viene sempre falsamente paragonata, a un’affermazione come «è impossibile per un essere umano attraversare a nuoto l’Atlantico»; ma è analoga a un’affermazione come «non c’è traguardo in una gara di resistenza». E questa è una delle cose avvertite debolmente da chi è insoddisfatto della spiegazione secondo cui si non può sapere… si può solo congetturare…
Se siamo arrabbiati con qualcuno perché in una fredda giornata è uscito con il raffreddore, talvolta diciamo: «Non ce l’ho mica io il tuo raffreddore». Ciò può significare: «Non soffro quando tu prendi il raffreddore». Questa è una proposizione insegnataci dall’esperienza. Perché potremmo immaginare una connessione, per così dire, senza fili tra due corpi che facesse sentire dolore nella testa a una persona quando l’altro esponesse la propria all’aria fredda. In questo caso si potrebbe argomentare che i dolori sono miei perché sono sentiti nella mia testa; immagina però che io e qualcun altro avessimo parte dei nostri corpi in comune, diciamo una mano. Immagina che i nervi e i tendini del mio braccio e del braccio di A fossero connessi a questa mano grazie a un’operazione. Ora immagina la mano punta da una vespa. Piangiamo entrambi, i nostri volti si contorcono, forniamo la stessa descrizione del dolore, ecc. Dovremmo dire di provare lo stesso dolore o dolori diversi? Se in tal caso tu dici: «Sentiamo dolore nello stesso punto, nello stesso corpo, le nostre descrizioni combaciano, tuttavia il mio dolore non può essere il suo», suppongo che per giustificare tale affermazione tu sia propenso a dire: |(Ts-309,91) «Perché il mio dolore è il mio dolore e il suo dolore è il suo dolore». E qui stai facendo un’affermazione grammaticale sull’uso di una locuzione quale «lo stesso dolore». Dici che non desideri usare la locuzione «lui ha il mio dolore» o «abbiamo entrambi lo stesso dolore» e invece magari userai una locuzione quale «il suo dolore è esattamente come il mio». (Non sarebbe una confutazione dire che i due non possono avere lo stesso dolore perché qualcuno potrebbe anestetizzare o uccidere l’uno mentre l’altro continua a provare dolore.) Naturalmente, se escludiamo l’espressione «ho il suo mal di denti» dal nostro linguaggio, escludiamo perciò anche «ho (o sento) il mio mal di denti». Un’altra forma della nostra affermazione metafisica è questa: «I dati sensoriali di una persona sono soltanto suoi, privati». Questo modo di esprimersi è ancora più fuorviante, perché pare ancora più simile a una proposizione empirica; il filosofo che dice così può ben pensare di star esprimendo una sorta di verità scientifica.
Impieghiamo la locuzione «due libri hanno lo stesso colore», ma potremmo benissimo dire: «non possono avere lo stesso colore, perché, in fondo, questo libro ha il suo colore e quel libro ha a sua volta il suo colore». Anche questo sarebbe affermare una regola grammaticale, – una regola in disaccordo con il nostro uso ordinario. La ragione per cui si dovrebbe pensare a questi due usi diversi è la seguente: confrontiamo il caso dei dati sensoriali con quello dei corpi fisici, nel quale facciamo una distinzione tra «questa è la stessa sedia che ho visto un’ora fa» e «questa non è la stessa sedia, ma una sedia esattamente |(Ts-309,92) identica all’altra». Qui ha senso dire, e si tratta di una proposizione empirica: «A e B non possono aver visto la stessa sedia, perché A era a Londra e B era a Cambridge; hanno visto due sedie esattamente identiche». (Qui sarà utile considerare i diversi criteri per ciò che chiamiamo «identità di questi oggetti». Come applichiamo le affermazioni: «questo è lo stesso giorno…», «questa è la stessa parola…», «questa è la stessa occasione…», ecc.?)
Ciò che abbiamo fatto in queste discussioni è stato quello che facciamo sempre quando ci imbattiamo nella parola «può» in una proposizione metafisica. Mostriamo che questa proposizione nasconde una regola grammaticale. Ovverosia, distruggiamo la somiglianza esteriore tra una proposizione metafisica e una proposizione empirica e cerchiamo di trovare la forma di espressione che soddisfa una certa brama dei metafisici che il nostro linguaggio ordinario non soddisfa e che, finché resta insoddisfatta, produce lo sconcerto metafisico. Di nuovo, quando in un senso metafisico dico «quando provo dolore devo sempre saperlo», ciò rende semplicemente la parola «sapere» ridondante; invece di «so che provo dolore», posso tranquillamente dire «provo dolore». Naturalmente, la situazione cambia se diamo un senso alla locuzione «dolore inconscio», fissando criteri empirici per il caso in cui qualcuno ha dolore e non lo sa, e se poi diciamo (giustamente o erroneamente) che di fatto nessuno ha mai provato dolore senza saperlo.
Quando diciamo «non posso sentire il suo dolore» ci si suggerisce l’idea di una |(Ts-309,93) barriera insormontabile. Pensa subito a un caso simile: «I colori verde e blu non possono essere contemporaneamente nello stesso punto». Qui l’immagine d’impossibilità fisica che ci si suggerisce non è, forse, quella di una barriera; sentiamo invece che i due colori si ostacolano reciprocamente. Qual è l’origine di quest’idea? – Diciamo che tre persone non possono sedersi una accanto all’altra su questa panca; non c’è spazio. Il caso dei colori non è analogo a questo; ma è in qualche modo analogo al dire: «un metro e mezzo non ci sta tre volte in un metro». Questa è una regola grammaticale e afferma un’impossibilità logica. La proposizione «tre uomini non possono sedersi l’uno accanto all’altro su una panca di un metro scarso» afferma un’impossibilità fisica; e questo esempio mostra chiaramente perché le due impossibilità sono confuse. (Confronta la proposizione «lui è quindici centimetri più alto di me» con «1,80 metri è 15 centimetri più di 1,65 metri». Le due proposizioni sono di tipo assolutamente diverso, ma sono perfettamente somiglianti.) La ragione per cui in questi casi ci si suggerisce l’idea dell’impossibilità fisica è che da un lato decidiamo di non usare una particolare forma di espressione, dall’altro siamo fortemente tentati di usarla, innanzitutto perché ci sembra ottimo inglese o ottimo tedesco ecc. e poi, secondariamente, perché ci sono forme di espressioni molto simili che vengono impiegate in altri settori del nostro linguaggio. Abbiamo deciso di non usare la locuzione «quelle due cose sono nello stesso luogo, ecc.»; tuttavia essa ci si raccomanda fortemente attraverso l’analogia con |(Ts-309,94) altri casi, in modo tale che noi, in un certo senso, dobbiamo espellere questa forma di espressione con la forza. Ecco perché abbiamo l’impressione di stare rifiutando una proposizione universalmente falsa. Ci facciamo un’immagine come quella dei due colori che si ostacolano reciprocamente, o di una barriera che non permette a una persona di avvicinarsi all’esperienza di un altro più che osservandone il comportamento; ma guardando più da vicino ci accorgiamo di non poter applicare l’immagine che ci siamo fatti.
Il nostro oscillare tra impossibilità logica e fisica ci porta a fare affermazioni come la seguente: «Se ciò che sento è sempre il mio dolore e basta, che cosa può significare la supposizione che qualcun altro provi dolore?». Ciò che va fatto in questi casi è sempre guardare come le parole in questione sono effettivamente usate nel nostro linguaggio. In tutti questi casi pensiamo a un uso diverso da quello che il nostro linguaggio ordinario fa di tali parole. A un uso, però, che proprio in quel momento per qualche ragione ci si raccomanda fortemente. Quando qualcosa nella grammatica delle nostre parole sembra bizzarro, è perché siamo alternativamente tentati di utilizzare una parola in vari sensi diversi. E scoprire che un’asserzione fatta dal metafisico esprime insoddisfazione nei confronti della nostra grammatica è particolarmente difficile quando le parole di tale asserzione possono anche essere impiegate per descrivere un fatto empirico. Così, quando costui dice «solo il mio dolore è vero dolore», questa frase potrebbe significare che le altre persone si limitano a fingere. E se il metafisico dice «quando nessuno lo vede, quest’albero non esiste», ciò potrebbe significare «quest’albero |(Ts-309,95) svanisce quando gli voltiamo le spalle». Chi dice «solo il mio dolore è reale» non intende dire che ha stabilito in basi ai criteri comuni – i criteri, cioè, che danno alle parole i loro significati comuni – che gli altri che dicevano di provare dolore mentivano. Ciò contro cui costui si ribella è l’uso di quest’espressione in connessione con questi criteri. Egli, cioè, protesta contro l’impiego di questa parola nel particolare modo in cui viene comunemente usata. D’altro canto, egli non si rende conto di protestare contro una convenzione. Vede una maniera di dividere il Paese diverso da quello utilizzato nella cartina ordinaria. Si sente tentato, diciamo, di utilizzare il nome «Devonshire» non per la contea con i suoi confini convenzionali, ma per una regione dai confini diversi. Potrebbe esprimere ciò dicendo: «Non è assurdo fare di questo una contea, tirare i confini qui?». Ma ciò che dice è: «Il vero Devonshire è questo». Potremmo rispondere: «Ciò che vuoi è soltanto una nuova notazione e con una nuova notazione non cambia alcun fatto geografico». Tuttavia, è vero che possiamo essere irresistibilmente attratti o respinti da una notazione. (Dimentichiamo facilmente quanto una notazione, una forma d’espressione, può significare per noi e che cambiarla non è sempre tanto facile quanto spesso è invece nella matematica o nelle scienze. Un cambio d’abiti o di nomi può significare pochissimo e può significare moltissimo.)
Cercherò di chiarire il problema discusso da realisti, idealisti e solipsisti mostrandovi un problema a esso strettamente legato. È questo: «Possiamo avere pensieri inconsci, |(Ts-309,96) sentimenti inconsci, ecc.?». L’idea che ci siano pensieri inconsci ha disgustato molte persone. Altri invece hanno detto che costoro sbagliavano a supporre che ci potessero essere soltanto pensieri consci e che la psicanalisi ha scoperto pensieri inconsci. Gli oppositori del pensiero inconscio non si rendevano conto che le loro obiezioni non riguardavano le reazioni psicologiche scoperte di recente, ma il modo in cui venivano descritte. Gli psicanalisti, d’altra parte, fuorviati dal loro stesso modo di esprimersi, pensavano di aver conseguito ben più della scoperta di nuove reazioni psicologiche; ritenevano di aver, in qualche modo, scoperto pensieri consci che erano inconsci. I primi avrebbero potuto formulare la propria obiezione dicendo «non vogliamo usare la locuzione “pensieri inconsci”; vogliamo riservare la parola “pensiero” a ciò che chiamiamo “pensieri consci”». Sbagliano a formulare il proprio punto di vista dicendo: «Ci possono solo essere pensieri consci e non pensieri inconsci». Perché, se non desiderano parlare di «pensieri inconsci», non dovrebbero impiegare la locuzione «pensieri consci».
Ma non è giusto dire che, in ogni caso, la persona che parla sia di pensieri consci sia di pensieri inconsci, così facendo, utilizza la parola «pensiero» in due modi diversi? Usiamo un martello in due modi diversi quando battiamo un chiodo e quando invece infiliamo un piolo in una fessura? E lo usiamo in due modi diversi oppure nello stesso modo quando infiliamo il piolo in questa fessura e quando invece infiliamo un altro piolo in un’altra |(Ts-309,97) fessura? Oppure dovremmo chiamarli usi diversi soltanto quando in un caso infiliamo una cosa in un’altra e nell’altro caso spacchiamo qualcosa? Oppure tutto questo è sempre usare il martello in un solo modo e bisogna chiamarlo un modo diverso solo quando si usa il martello come fermacarte? – In quali casi dobbiamo dire che una parola è usata in due modi diversi e in quali che è usata in un modo solo? Dire che una parola è usata in due (o più) modi, in sé, non ci dà ancora un’idea del suo uso. Specifica soltanto un modo di guardare a quest’utilizzo fornendo uno schema con due (o più) suddivisioni per la sua descrizione. Va bene dire: «Faccio due cose con questo martello: pianto un chiodo in quest’asse e uno in quell’asse». Ma avrei potuto dire anche: «Sto facendo una cosa sola con questo martello; sto piantando un chiodo in quest’asse e uno in quell’asse». Possono esserci due tipi di discussione per chiarire «se una parola è usata in un modo o in due modi»: a) Due persone possono discutere se la parola italiana «attaccare» è impiegata soltanto per aggredire qualcosa o anche per unire due cose. Questa è una discussione che riguarda gli atti di un certo impiego effettivo. b) Costoro possono discutere se la parola «altus», che sta per «profondo» e «alto», è perciò usata in due modi diversi. Questa domanda è analoga alla domanda se la parola «pensiero» è usata in due modi o in un modo solo quando parliamo di pensiero conscio e inconscio. Chi dice «certamente si tratta di due usi diversi» ha già deciso di impiegare uno schema |(Ts-309,98) dualistico e la sua affermazione ha espresso tale decisione.
Ora quando il solipsista dice che solo le sue esperienze sono reali, non serve a nulla rispondergli: «Perché ce lo dici se non credi che lo sentiamo davvero?». O comunque, se gli diamo tale risposta, non dobbiamo credere di aver risposto alla sua difficoltà. Non c’è risposta di senso comune a un problema filosofico. Si può difendere il senso comune dagli attacchi dei filosofi soltanto risolvendo le loro perplessità, ossia guarendoli dalla tentazione di attaccare il senso comune; non ribadendo le concezioni del senso comune. Un filosofo non è un folle, uno che non vede ciò che vede chiunque altro; né d’altra parte il suo disaccordo con il senso comune è quello dello scienziato che dissente dalle rozze concezioni dell’uomo della strada. Ovverosia, il disaccordo del filosofo non è fondato su una conoscenza più sottile dei fatti. Perciò dobbiamo guardarci attorno alla ricerca della fonte del suo sconcerto. E ci accorgiamo che sorgono sconcerto e disagio mentale non soltanto quando la nostra curiosità su certi fatti non è soddisfatta o quando non riusciamo a trovare una legge naturale che combacia con tutta la nostra esperienza, ma anche quando una notazione non ci soddisfa, – magari a causa di varie associazioni che essa richiama. Il nostro linguaggio ordinario, che tra tutte le notazioni possibili è quella che pervade la nostra vita, tiene ferma per così dire la nostra mente in una posizione fissa, e stando in tale posizione talvolta sentiamo come un crampo e abbiamo il desiderio di trovare altre posizioni. Quindi in certi casi vorremmo una notazione che sottolinei |(Ts-309,99) una differenza con più forza di quanto fa il linguaggio ordinario, che la renda più evidente, oppure una notazione che in un caso particolare impieghi forme d’espressione più simili tra loro di quanto fa il nostro linguaggio ordinario. Il crampo mentale si allenta quando ci si mostrano le notazioni che soddisfano tali necessità. Queste necessità possono essere molto varie.
Colui che chiamiamo un solipsista, e che dice che solo le sue esperienze sono reali, da un lato non è con ciò in disaccordo con noi riguardo a qualsivoglia questione pratica e fattuale, non afferma che quando ci lamentiamo di un dolore stiamo simulando, ci compatisce come chiunque altro, ma al contempo vorrebbe restringere l’impiego dell’epiteto «reale» a ciò che dovremmo chiamare le sue esperienze; e magari non vuole affatto chiamare «esperienze» le nostre esperienze (di nuovo, senza essere in disaccordo con noi su alcuna questione di fatto). Perché costui direbbe che è inconcepibile che altre esperienze che le sue siano reali. Dovrebbe dunque utilizzare una notazione in cui una locuzione quale «A ha realmente mal di denti» (dove A non è lui) è priva di significato, una notazione le cui regole escludono tale locuzione come le regole degli scacchi escludono che un pedone si muova come un cavallo. Ciò che il solipsista in fondo suggerisce è di usare una locuzione come «c’è mal di denti reale» al posto di «Smith (il solipsista) ha mal di denti». E perché non dovremmo concedergli questa notazione? È evidente che per evitare confusioni in questo caso non avrebbe proprio dovuto usare la parola «reale» in contrapposizione a «simulato»; il che significa soltanto che dovremmo provvedere alla |(Ts-309,100) distinzione tra «reale» e «simulato» in qualche altro modo. Il solipsista che dice «solo io sento realmente dolore», «solo io vedo (o sento) realmente» non sta affermando un’opinione; per questo è così sicuro di ciò che afferma. Ha la tentazione irresistibile di impiegare una certa forma d’espressione; ma dobbiamo ancora scoprire perché.
La locuzione «solo io vedo realmente» è strettamente connessa con l’idea espressa nell’asserzione «non sappiamo mai che cosa vede davvero il prossimo quando guarda una cosa» oppure «non possiamo mai sapere se chiama “blu” la stessa cosa che noi chiamiamo “blu”». Infatti, potremmo argomentare: «Non posso mai sapere che cosa vede lui o se lui vede o meno, perché tutto ciò che ho sono segni di vario genere che lui mi dà; dunque che lui veda è un’ipotesi assolutamente non necessaria; ciò che è vedere io lo so solo in base al fatto che vedo io; ho imparato la parola solo per intendere ciò che faccio io». Naturalmente, ciò semplicemente non è vero, perché ho senza dubbio imparato un uso diverso e ben più complicato della parola «vedere» rispetto a quanto ho professato or ora. Chiariamo ora la tendenza che mi ha guidato a esprimermi così, facendo un esempio preso da una sfera leggermente diversa: considera quest’argomento: «Come possiamo desiderare che questo foglio sia rosso se non è rosso? Non significherebbe che desidero ciò che non esiste affatto? Dunque, il mio desiderio può solo contenere qualcosa di simile al colore rosso del foglio. Non dovremmo allora impiegare una parola diversa invece di “rosso” quando parliamo di desiderare che qualcosa sia rosso?». L’immagine del desiderio certamente ci mostra qualcosa di meno definito, qualcosa di più vago, rispetto alla realtà |(Ts-309,101) del colore rosso del foglio.
Dovrei dunque dire, invece di «vorrei che questo foglio fosse rosso», qualcosa come «per questo foglio vorrei un rosso pallido». Ma se nel modo abituale di parlare lui avesse detto «per questo foglio vorrei un rosso pallido», noi per soddisfare tale desiderio avremmo dovuto dipingerlo di rosso pallido – e non era questo il suo desiderio. D’altra parte, non ci sono controindicazioni ad adottare la forma d’espressione da lui suggeritaci finché sappiamo che lui usa sempre la locuzione «per questo foglio vorrei un x pallido» per significare ciò che ordinariamente noi esprimiamo con «vorrei che questo foglio avesse il colore x». Ciò che ha detto in realtà raccomandava la sua notazione, nel senso in cui una notazione può essere raccomandata. Non ci ha però detto una nuova verità e non ci ha mostrato che ciò che dicevamo prima era falso. (Tutto ciò connette questo nostro problema con il problema della negazione. Vi darò solo un indizio dicendo che è possibile una notazione in cui, per dirlo approssimativamente, una qualità ha sempre due nomi, uno per il caso in cui si dice che qualcosa ce l’ha, l’altro per il caso in cui si dice che qualcosa non ce l’ha. La negazione di «questo foglio è rosso» potrebbe dunque essere, poniamo, «questo foglio non è roro». Una tale notazione esaudirebbe effettivamente alcuni dei desideri che ci sono preclusi dal linguaggio ordinario e che talvolta producono un crampo di sconcerto filosofico a proposito dell’idea della negazione.)
La difficoltà che esprimiamo dicendo «non possiamo sapere ciò che lui vede quando afferma (dicendo la verità) di vedere una macchia blu» sorge dall’idea che «sapere ciò che lui vede» significa |(Ts-309,102) «vedere ciò che vede anche lui»; non tuttavia nel senso in cui vediamo ciò che vede anche lui quando entrambi abbiamo sotto gli occhi lo stesso oggetto: ma nel senso in cui l’oggetto visto sarebbe un oggetto, poniamo, nella sua testa, o in lui. L’idea è che lo stesso oggetto può essere sotto i suoi occhi e sotto i miei, ma che non posso infilare la testa dentro la sua (o la mente dentro la sua, che in fondo è lo stesso) in modo che l’oggetto reale e immediato del suo vedere diventi l’oggetto reale e immediato anche del mio vedere. Con «non so ciò che vede» intendiamo, in realtà, «non so ciò che guarda», poiché «ciò che guarda» è nascosto e lui non può mostrarmelo; è davanti all’occhio della sua mente. Quindi, per sbarazzarti del dilemma, esamina la differenza grammaticale tra le affermazioni «non so ciò che vede» e «non so ciò che guarda» per come sono effettivamente usate nel nostro linguaggio.
Talvolta l’espressione più soddisfacente del nostro solipsismo pare essere questa: «Quando una cosa viene vista (davvero vista), sono sempre io che la vedo».
Ciò che in quest’espressione dovrebbe colpirci è la locuzione «sempre io». Sempre chi? – Poiché, bizzarro, non intendo: «sempre L.W.». Questo ci porta a considerare i criteri per l’identità di una persona. In quali circostanze diciamo: «Questa è la stessa persona che ho visto un’ora fa»? Il nostro uso effettivo della locuzione «la stessa persona» e dei nomi di persona è basato sul fatto che molte caratteristiche che usiamo come criteri d’identità coincidono nella stragrande |(Ts-309,103) maggioranza dei casi. Di regola vengo riconosciuto per l’aspetto del mio corpo. Il mio corpo cambia aspetto solo gradualmente e in misura piuttosto limitata, proprio come la mia voce, le mie abitudini caratteristiche, ecc. cambiano solo lentamente e, nel complesso, non di molto. Siamo portati a usare i nomi di persona nel modo in cui li usiamo solo in conseguenza di tali fatti. La maniera migliore per accorgersene consiste nell’immaginare casi fittizi che ci mostrano quali diverse «geometrie» saremmo propensi a utilizzare se i fatti fossero diversi. Immagina, per esempio, che tutti i corpi umani esistenti avessero lo stesso aspetto e che d’altro canto vari insiemi di caratteristiche sembrassero, per così dire, cambiare di residenza tra questi corpi. Un tale insiemi di caratteristiche potrebbe essere, poniamo, la mitezza accompagnata da una voce acuta e da movimenti lenti, oppure un temperamento collerico, una voce profonda e movimenti che procedono a scatti, o simili. In circostanze del genere, pur essendo possibile dare nomi ai corpi, saremmo forse tanto poco propensi a farlo quanto lo siamo a dare nomi alle sedie della nostra sala da pranzo. Tuttavia, sarebbe utile dare nomi agli insiemi di caratteristiche e l’uso di tali nomi corrisponderebbe più o meno a quello dei nomi di persona nel nostro attuale linguaggio.
Oppure immagina che normalmente un uomo abbia due personaggi, nel seguente modo: la sua forma, la sua stazza e le caratteristiche del suo comportamento ogni tanto cambiano inspiegabilmente. È normale che un uomo abbia due di questi stati e che improvvisamente scivoli dall’uno all’altro. È molto probabile che in tal |(Ts-309,104) caso saremmo portati a battezzare ogni uomo con due nomi e magari a parlare delle due persone presenti nel suo corpo. Il dottor Jekyll e Mr Hyde erano due persone oppure erano la stessa persona che semplicemente cambiava? Possiamo scegliere l’alternativa che preferiamo. Non siamo costretti a parlare di doppia personalità.
Ci sono molti usi della parola «personalità» che possiamo sentirci portati ad adottare, tutti più o meno analoghi. Lo stesso vale quando definiamo l’identità di una persona per mezzo dei suoi ricordi. Immagina un uomo i cui ricordi, durante i giorni pari della sua vita, includono gli eventi di tutti i giorni pari, ma saltando completamente i giorni dispari; d’altra pare, nei giorni dispari l’uomo ricorda ciò che è accaduto nei giorni dispari precedenti, ma la sua memoria salta i giorni pari senza alcuna sensazione di discontinuità. Se ci aggrada, possiamo supporre anche che, a seconda che si tratti di un giorno pari o dispari, costui abbia aspetti e caratteristiche diverse. Dobbiamo dire che qui due persone stanno abitando lo stesso corpo? Cioè, è giusto dire che ci sono due persone, e sbagliato dire che non ci sono, oppure viceversa? Nessuna delle due. Perché l’uso ordinario della parola «persona» è ciò potremmo chiamare un uso composito adatto alle circostanze ordinarie. Se presuppongo, come sto facendo ora, che tali circostanze siano cambiate, l’applicazione del termine «persona» o «personalità» è per ciò stesso cambiato, e se desidero preservare tale termine e fornirgli un uso analogo al suo uso precedente, sono libero di scegliere tra molti usi, cioè tra molti tipi diversi di analogia. Si potrebbe dire che in un caso simile |(Ts-309,105) il termine «personalità» non ha un unico erede legittimo. (Questo tipo di considerazione è rilevante nella filosofia della matematica. Considera l’uso delle parole «dimostrazione», «formula», e altre. Considera la domanda: «Perché ciò che facciamo qui dovrebbe essere chiamato “filosofia?” Perché dovrebbe essere visto come l’unico erede legittimo delle diverse attività che in passato avevano questo nome?»)
Ora chiediamoci a che genere di identità di personalità ci stiamo riferendo quando diciamo: «Quando una cosa viene vista, sono sempre io che vedo». Che cos’è che voglio che abbiano in comune tutte queste istanze del vedere? Come risposta, devo confessare a me stesso che non si tratta del mio aspetto corporeo. Quando vedo, non vedo sempre parte del mio corpo. E non è essenziale che il mio corpo, se visto tra le cose che vedo, debba sempre avere lo stesso aspetto. In effetti, non mi interessa quanto esso cambia. E i miei sentimenti sono gli stessi nei confronti delle proprietà del mio corpo, delle caratteristiche del mio comportamento e persino dei miei ricordi. – Pensandoci un po’ più a lungo mi accorgo che ciò che desideravo dire era: «Sempre, quando una cosa viene vista, qualcosa viene visto». Ossia, ciò di cui ho detto che continuava durante tutte le esperienze del vedere non era alcuna particolare entità «io», ma l’esperienza stessa del vedere. Ciò può divenire più chiaro se immaginiamo che l’uomo che fa la nostra affermazione solipsistica mentre dice «io» indichi i propri occhi. (Magari perché desidera essere esatto e vuole dire espressamente quali occhi appartengono alla bocca che dice «io» e |(Ts-309,106) alle mani che indicano il suo corpo.) Ma che cos’è che sta indicando? Questi particolari occhi con l’identità di oggetti fisici? (Per comprendere tale frase devi ricordare che la grammatica delle parole di cui diciamo che stanno per oggetti fisici è caratterizzata dal modo in cui utilizziamo la locuzione «lo stesso così e così», o «l’identico così e così» dove così e così designa l’oggetto fisico.) Abbiamo detto prima che non desideravamo affatto indicare un particolare oggetto fisico. L’idea che costui avesse fatto un’affermazione dotata di significato è sorta da una confusione corrispondente alla confusione tra ciò che chiameremo «l’occhio geometrico» e «l’occhio fisico». Indicherò l’uso di questi termini: se un uomo cerca di eseguire l’ordine «indica il tuo occhio», può fare molte cose diverse e ci sono molti criteri diversi per il fatto di aver indicato il proprio occhio che considererà accettabili. Se questi criteri, come accade di solito, coincidono, posso usarli alternativamente e in diverse combinazioni per mostrare a me stesso che mi sono toccato l’occhio. Se non coincidono, dovrò distinguere tra sensi diversi della locuzione «mi tocco l’occhio» o «muovo il dito verso il mio occhio». Se ho gli occhi chiusi, per esempio, posso comunque avere nel braccio la caratteristica esperienza cinestetica che chiamerei l’esperienza cinestetica di sollevare la mano verso l’occhio. Il fatto di esserci riuscito lo riconoscerò in base alla caratteristica sensazione tattile di toccarmi l’occhio. Ma se il mio occhio fosse dietro una lastra di vetro assicurata in modo tale da impedirmi |(Ts-309,107) di esercitare una pressione sull’occhio con il dito, ci sarebbe comunque un criterio di sensazione muscolare che mi farebbe dire che il dito è davanti all’occhio. Per quanto riguarda i criteri visivi, posso adottarne due. C’è l’esperienza ordinaria di vedere la mano alzarsi e avvicinarsi all’occhio, e questa esperienza naturalmente è diversa dal vedere due cose che si incontrano, per esempio due polpastrelli. D’altra parte, posso utilizzare come criterio per il fatto che il mio dito si muove verso l’occhio ciò che vedo quando guardo in uno specchio e vedo il dito accostarsi all’occhio. Se il punto del mio corpo che, come diciamo, «vede» va determinato muovendo il dito verso l’occhio, in accordo con il secondo criterio, allora è concepibile che io possa vedere con ciò che in base ad altri criteri è la punta del naso o qualche zona della fronte; oppure potrei indicare in questo modo un luogo posto fuori dal mio corpo. Se desidero che una persona indichi il proprio occhio (o i propri occhi) in base soltanto al secondo criterio, esprimerò il mio desiderio dicendo: «Indica il tuo occhio geometrico (o i tuoi occhi geometrici)». La grammatica della parola «occhio geometrico» sta con la grammatica della parola «occhio fisico» nella stessa relazione in cui la grammatica dell’espressione «il dato sensoriale visivo di un albero» sta alla grammatica dell’espressione «l’albero fisico». In entrambi i casi dire «l’uno è un tipo diverso di oggetto rispetto all’altro» confonde tutto; poiché chi dice che un dato sensoriale è un tipo di oggetto diverso da un oggetto fisico fraintende la grammatica della parola «tipo», proprio come chi dice che un numero è un tipo di |(Ts-309,108) oggetto diverso da un numerale. Chi dice così pensa di fare un’affermazione quale «un convoglio ferroviario, una stazione ferroviaria e un vagone ferroviario sono tipi diversi di oggetti», mentre la loro affermazione è analoga a «un convoglio ferroviario, un incidente ferroviario e una legge ferroviaria sono tipi diversi di oggetti».
A ciò che generava in me la tentazione di dire «sono sempre io che vedo quando qualcosa viene visto» avrei potuto cedere anche dicendo «ogni volta che qualcosa viene visto, è questo che viene visto», accompagnando la parola «questo» con un gesto che abbraccia il mio campo visivo (ma non intendendo con «questo» i particolari oggetti che si dava il caso io vedessi in quel momento). Si potrebbe dire «sto indicando il campo visivo in quanto tale, non qualcosa al suo interno». E questo serve soltanto a rendere evidente l’insensatezza dell’espressione precedente.
Sbarazziamoci allora del «sempre» nella nostra espressione. In tal caso posso comunque esprimere il mio solipsismo dicendo «solo ciò che io vedo (oppure: vedo ora) viene visto davvero». E qui sono tentato di dire: «Anche se con la parola “io” non intendo L.W., andrà bene lo stesso se gli altri intendono “io” come L.W. dal momento che proprio adesso io in effetti sono L.W.». Potrei anche esprimere la mia tesi dicendo: «Sono io il contenitore della vita»; ma sta’ attento, è essenziale che tutti coloro a cui lo dico siano incapaci di comprendermi. È essenziale che l’altro non sia in grado di comprendere «ciò che io davvero intendo», anche se nella pratica potrebbe fare ciò che desidero concedendomi una posizione eccezionale nella sua notazione. Ma io vorrei che fosse logicamente impossibile che lui mi capisse; cioè affermare che lui mi comprende dovrebbe essere privo di significato, |(Ts-309,109) non falso. Quindi la mia espressione è una tra le molte espressioni che vengono usate in varie occasioni dai filosofi e che dovrebbero comunicare qualcosa alla persona che le dice, pur essendo essenzialmente incapace di comunicare alcunché a chiunque altro. Ora, se comunicare un significato significa essere accompagnati da o produrre certe esperienze, la nostra espressione può avere tutto uno stuolo di significati, su cui io non sono in grado di dire nulla. Siamo però, di fatto, portati a pensare che la nostra espressione abbia un significato nel senso in cui ce l’ha un’espressione non metafisica; poiché paragoniamo erroneamente il nostro caso a un caso in cui l’altra persona non può comprendere ciò che diciamo perché ignora una certa informazione. (Questa osservazione può diventare chiara soltanto se comprendiamo la connessione tra grammatica e senso e nonsenso).
Il significato di una locuzione per noi è caratterizzato dall’impiego che ne facciamo. Il significato non è un accompagnamento mentale dell’espressione. Quindi la locuzione «penso d’intendere qualcosa con ciò», oppure «sono certo d’intendere qualcosa con ciò», che sentiamo così di frequente nei dibattiti filosofici per giustificare l’uso di un’espressione, per noi non è affatto una giustificazione. Chiediamo «cosa intendi?», cioè «come usi quest’espressione?». Se qualcuno mi insegna la parola «panca» e mi dice che talvolta o sempre traccia su di essa una linea in questo modo: «panca», e che questo per lui significa qualcosa, io dovrei dirgli: «Non so che genere d’idea tu associ a questa linea, ma non mi interessa a meno che tu non mi mostri che |(Ts-309,110) per essa esiste un uso nel tipo di calcolo in cui io desidero usare la parola “panca”». – Voglio giocare a scacchi e un uomo mette in testa al re bianco una corona di carta, senza alterare l’uso del pezzo, ma dicendomi che per lui la corona ha un significato nel gioco che lui non può esprimere sotto forma di regola. Gli dico: «Finché non altera l’uso del pezzo, non ha ciò che io chiamo un significato».
Talvolta si sente dire che una locuzione quale «questo è qui», quando la pronuncio indicando una zona del mio campo visivo, ha per me una sorta di significato primitivo, pur non potendo comunicare a nessun altro alcuna informazione.
Quando dico «solo questo viene visto», dimentico che una frase può suonarci assolutamente naturale senza avere alcun impiego nel calcolo del linguaggio. Pensa alla legge d’identità «a = a» e a come talvolta ci sforziamo di afferrarne il senso, di visualizzarlo, guardando un oggetto e ripetendo a noi stessi una frase quale «quest’albero è la stessa cosa di quest’albero». I gesti e le immagini con cui apparentemente do senso a questa frase sono molto simili a quelli che utilizzo nel caso di «solo questo è visto». (Per chiarire dei problemi filosofici, è utile divenire consapevoli dei dettagli apparentemente trascurabili della situazione particolare in cui siamo propensi a fare una certa asserzione metafisica. Così avremmo la tentazione di dire «solo questo viene davvero visto» quando fissiamo un ambiente statico, mentre non saremmo affatto tentati di dirlo quando ci guardiamo attorno |(Ts-309,111) camminando.) Non ci sono controindicazioni, come abbiamo detto, all’adozione di un simbolismo in cui una certa persona, sempre o temporaneamente, occupa una posizione eccezionale. Dunque, se pronuncio la frase «solo io vedo realmente», è concepibile che i miei simili aggiustino perciò la loro notazione in modo da allinearsi a me, dicendo «questo e questo viene visto realmente» invece di «L.W. vede questo e questo», ecc. Ciò che comunque è sbagliato è il fatto di pensare che io possa giustificare la scelta di tale notazione. Quando ho detto, dal cuore, che solo io vedo, ero anche portato a dire che con «io» non intendevo davvero L.W., anche se a beneficio dei miei simili potrei dire «adesso è L.W. che vede realmente», pur non essendo questo che davvero intendo. Potrei quasi dire che con «io» intendo qualcosa che proprio ora risiede in L.W., qualcosa che gli altri non possono vedere. (Intendevo la mia mente, ma potevo indicarla solo tramite il mio corpo.) Non c’è nulla di sbagliato nel suggerire che gli altri dovrebbero darmi una posizione eccezionale nella loro notazione, ma la giustificazione che vorrei fornire – che questo corpo è ora la sede di ciò che vive realmente – è priva di senso. Perché bisogna ammettere che dire così non equivale ad affermare qualcosa che nel senso ordinario è una questione empirica. (E non pensare che sia una proposizione empirica che solo io posso conoscere perché solo io sono nella posizione di avere questa particolare esperienza.) Ora, l’idea che l’io reale abiti nel mio corpo è connessa con la grammatica particolare della parola «io» e con i fraintendimenti a cui |(Ts-309,112) tale grammatica tende a dare adito. Ci sono due diversi casi dell’uso della parola «io» (oppure «mio»), che potrei chiamare «l’uso in quanto oggetto» e «l’uso in quanto soggetto» Esempi del primo tipo di uso sono questi: «il mio braccio è rotto», «io sono cresciuto di quindici centimetri», «io ho un bernoccolo sulla fronte», «il vento mi scompiglia i capelli». Esempi del secondo tipo sono: «io vedo questo e questo», «io sento questo e questo», «io pensò che pioverà», «io ho mal di denti». Si può indicare la differenza tra queste due categorie dicendo: i casi della prima categoria comportano il riconoscimento di una persona particolare e in questi casi c’è la possibilità di un errore, o anzi dovrei dire: è stata prevista la possibilità di un errore. La possibilità di fallire un punto è stata prevista nel flipper. D’altro canto, il fatto che le palline non vengano fuori se ho messo un centesimo nella fessura non è uno dei rischi del gioco. È possibile che, in un incidente, ad esempio, io senta un dolore al braccio, che veda un braccio rotto lungo il mio fianco e che pensi che sia mio, quando in realtà è del mio vicino. E potrei, guardando in uno specchietto, scambiare un bernoccolo sulla sua fronte per un bernoccolo sulla mia. Dall’altra parte, quando dico che ho mal di denti, non si tratta affatto di riconoscere una persona. Chiedere «sei sicuro di essere tu a provare dolore?» sarebbe privo di senso. Ora, quando in questo caso non è possibile alcun errore, è perché la mossa che potremmo essere propensi a considerare un errore, una «mossa sbagliata», non è affatto una mossa del gioco. (Distinguiamo negli scacchi tra buone e cattive mosse e, se esponiamo la |(Ts-309,113) regina a un alfiere, lo chiamiamo un errore. Ma promuovere un pedone a re non è un errore.) E ora questo modo di formulare la nostra idea ci si suggerisce da solo: è altrettanto impossibile che nell’affermare «ho mal di denti» io abbia scambiato un’altra persona per me stesso quanto lo è gemere di dolore per errore, avendo scambiato qualcun altro per me stesso. Dire «ho dolore» non è fare un’affermazione su una persona particolare più di quanto non lo sia gemere. «Ma certamente la parola “io” in bocca a un uomo si riferisce all’uomo che la pronuncia; indica lui stesso; e molto spesso chi la dice indica se stesso con il dito». Indicare se stesso però era assolutamente superfluo. Avrebbe potuto anche solo alzare la mano. Sarebbe sbagliato dire che quando qualcuno indica il sole con la mano indica sia il sole sia se stesso perché è lui che indica; d’altra parte, indicando può attrarre l’attenzione sia sul sole sia su di sé.
La parola «io» non significa lo stesso di «L.W.» neanche se io sono L.W., né ha lo stesso significato dell’espressione «la persona che ora sta parlando». Ciò però non significa: «L.W.» e «io» significano cose diverse. Significa soltanto che queste parole sono strumenti diversi nel nostro linguaggio. Pensa alle parole come a strumenti caratterizzati dal loro uso e poi pensa all’uso di un martello, all’uso di un cesello, all’uso di una squadra, di un barattolo per la colla e della colla. (Inoltre, tutto ciò che diciamo qui può essere compreso solo se comprendi che una gran varietà di giochi è giocata con le frasi del |(Ts-309,114) nostro linguaggio: dare ed eseguire ordini; porre domande e rispondervi; descrivere un evento; raccontare una storia inventata; fare una battuta; descrivere un’esperienza immediata; fare congetture su eventi nel mondo fisico; costruire ipotesi scientifiche e teorie; salutare qualcuno, ecc. ecc.) La bocca che dice «io» o la mano che si solleva a indicare che sono io che desidero parlare, o io che ho mal di denti, non indica nulla di per sé. Se, invece, desidero indicare il luogo del mio dolore, indico. Qui, di nuovo, rammenta la differenza tra l’atto d’indicare il punto dolente senza venir guidato dall’occhio e l’atto d’indicare invece la cicatrice sul mio corpo dopo averla cercata. («È qui che mi hanno vaccinato».) – L’uomo che grida di dolore, o che dice di avere dolore, non sceglie la bocca che lo dice.
Tutto ciò si riduce al dire che la persona di cui diciamo «ha dolore» è, secondo le regole del gioco, la persona che urla, contorce il viso, ecc. Il luogo del dolore – come abbiamo detto – può essere nel corpo di un’altra persona. Se, nel dire «io», indico il mio corpo, modello l’uso della parola «io» su quello del dimostrativo «questa persona» o «lui». (Questo modo di rendere simili le due espressioni è in qualche modo analogo a quello che si adotta a volte nella matematica, per esempio nella prova che la somma dei tre angoli di un triangolo è di 180°.
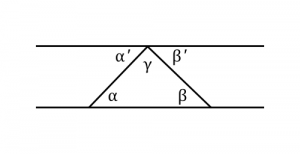
Diciamo che «α = α'», «β = β'» e «γ = γ». Le prime due uguaglianze sono di un tipo completamente |(Ts-309,115) diverso rispetto alla terza.) In «io ho dolore», «io» non è un pronome dimostrativo.
Confronta i due casi: 1. «Come sai che lui ha dei dolori?» – «Perché lo sento gemere». 2. «Come sai che tu hai dei dolori?» – «Perché li sento». Ma «li sento» significa lo stesso di «li ho». Quindi questa non era affatto una spiegazione. Il fatto che, comunque, nella mia risposta io sia portato a sottolineare la parola «sentire» e non la parola «io» indica che non desidero scegliere una persona (tra altre persone).
La differenza tra le proposizioni «io ho dolore» e «lui ha dolore» non è la stessa che tra «L. W. ha dolore» e «Smith ha dolore». Corrisponde invece alla differenza tra gemere e dire che qualcuno geme. – «Ma certamente la parola “io” in “io ho dolore” serve a distinguermi da altre persone, perché è con il segno “io” che distinguo il dire che ho dolore dal dire che ce l’ha uno degli altri.» Immagina un linguaggio in cui, invece di «non ho trovato nessuno nella stanza» si dicesse «ho trovato Mr Nessuno nella stanza». Immagina i problemi filosofici che sorgerebbe da una notazione simile. Alcuni filosofi educati in tale linguaggio probabilmente avrebbero la sensazione di non gradire la somiglianza tra le espressioni «Mr Nessuno» e «Mr Smith». Quando abbiamo la sensazione di voler abolire l’«io» in «io ho dolore», si può dire che tendiamo a rendere l’espressione verbale del dolore simile all’espressione del gemito. – Siamo propensi a dimenticare |(Ts-309,116) che è soltanto il suo uso particolare a dare a una parola il suo significato. Pensiamo al nostro vecchio esempio per l’uso delle parole: si manda qualcuno dal fruttivendolo con un foglietto su cui sono state scritte le parole «cinque mele». L’uso della parola nella pratica è il suo significato. Immagina che normalmente gli oggetti attorno a noi portino delle etichette con scritte sopra le parole con cui il nostro discorso si riferisce a tali oggetti. Alcune di queste parole sarebbero i nomi propri degli oggetti, altre nomi generici (come tavolo, sedia, ecc.), altri ancora nomi di colori, nomi di forme, ecc. Ovverosia, un’etichetta avrebbe per noi un significato soltanto nella misura in cui noi ne facciamo un particolare uso. Ora, si può facilmente immaginare che a impressionarci sia il semplice fatto di vedere un’etichetta su una cosa, e che quindi dimentichiamo che ciò che rende importanti queste etichette è il loro uso. In questo modo, talvolta, crediamo di aver nominato qualcosa quando facciamo un gesto per indicarlo e pronunciamo le parole «questo è…» (la formula della definizione ostensiva). Diciamo che chiamiamo qualcosa «mal di denti» e pensiamo che la parola abbia ricevuto una funzione definita nelle operazioni che svolgiamo con il linguaggio quando, in certe circostanze, ci siamo indicati la guancia e abbiamo detto: «Questo è mal di denti». (La nostra idea è che, se noi indichiamo e l’altro «solo sa ciò che indichiamo», allora lui sa usare la parola. Qui abbiamo in mente il caso speciale in cui «ciò che indichiamo» è, poniamo, una persona e «sapere ciò che indico» significa vedere quale delle persone presenti sto indicando). |(Ts-309,117)
Abbiamo l’impressione che nei casi in cui «io» è usato come soggetto, non lo impieghiamo perché riconosciamo una persona particolare in base alle sue caratteristiche corporee; questo crea l’illusione che usiamo tale parola per riferirci a qualcosa di incorporeo che, tuttavia, ha sede nel nostro corpo. In effetti, questo sembra essere l’ego reale, quello di cui si è detto «cogito, ergo sum». – «Dunque non c’è mente, ma solo un corpo?» Risposta: la parola «mente» ha significato, cioè ha un uso nel nostro linguaggio; ma dire questo non dice ancora che tipo di uso ne facciamo.
In effetti si può dire che ciò di cui ci preoccupiamo nelle nostre ricerche sia la grammatica di queste parole che descrivono ciò che chiamiamo «attività mentali»; vedere, sentire, provare, ecc. E ciò equivale a dire che ci occupiamo della grammatica delle «locuzioni che descrivono i dati sensoriali».
I filosofi dicono, come se fosse un’opinione o una convinzione filosofica, che ci sono dati sensoriali. Ma dire che credo che ci siano dati sensoriali equivale a dire che credo che un oggetto possa apparire davanti ai miei occhi anche quando non lo è. Ora, quando si usa la locuzione «dato sensoriale», si dovrebbe aver chiara la peculiarità della sua grammatica. Perché l’idea, nell’introdurre tale espressione, era modellare espressioni che si riferiscono all’«apparenza» su espressioni che si riferiscono alla «realtà». Si è detto per esempio che se due cose sembrano essere uguali, devono esserci due qualcosa che sono uguali. Ciò naturalmente |(Ts-309,118) significa soltanto che abbiamo deciso di utilizzare un’espressione quale «l’apparenza di questa cosa e l’apparenza di quella sono uguali» quale sinonimo di «queste due cose sembrano essere uguali». Stranamente, l’introduzione di tale nuova fraseologia ha illuso molte persone di aver scoperto nuove entità, nuovi elementi della struttura del mondo, come se dire «credo che ci siano dati sensoriali» fosse simile a dire «credo che la materia sia costituita da elettroni». Quando parliamo apparenze uguali o di dati sensoriali uguali, introduciamo un nuovo utilizzo della parola «uguale». È possibile che le lunghezze A e B ci appaiano uguali, che B e C ci appaiano uguali, ma che A e C non ci appaiano uguali. E nella nuova notazione dovremo dire che anche se l’apparenza (dato sensoriale) di A è uguale a quella di B e l’apparenza di B è uguale a quella di C, l’apparenza di A non è uguale all’apparenza di C; il che va bene, se non ti dispiace usare «uguale» intransitivamente.
Il pericolo in cui ci troviamo quando adottiamo la notazione del dato sensoriale è di dimenticare la differenza tra la grammatica di un’affermazione sui dati sensoriali e la grammatica di un’affermazione, esteriormente simile, su oggetti fisici. (Da qui si potrebbe proseguire parlando dei fraintendimenti che trovano espressione in frasi come: «Non potremo mai vedere una circonferenza precisa», «tutti i nostri dati sensoriali sono vaghi». Ciò porta inoltre al confronto della grammatica di «posizione», «moto» e «dimensione» nello spazio euclideo e nello spazio visivo. Ci sono, |(Ts-309,119) per esempio, posizione assoluta, moto e dimensione assoluti nello spazio visivo.)
Ora, possiamo usare un’espressione quale «indicare l’apparenza di un corpo» oppure «indicare un dato sensoriale visivo». Parlando approssimativamente, questo tipo d’indicare equivale al puntare, poniamo, la canna di una pistola. Quindi possiamo indicare e dire: «Questa è la direzione in cui vedo la mia immagine nello specchio». Si possono anche usare espressioni come «l’apparenza, o il dato sensoriale, del mio dito indica il dato sensoriale dell’albero» e simili. Da queste istanze dell’indicare, tuttavia, dobbiamo distinguere le istanze dell’indicare nella direzione da cui pare provenire un suono, o dell’indicarmi la fronte tenendo gli occhi chiusi, ecc.
Quando nella maniera solipsistica dico «questo è ciò che viene realmente visto», indico davanti a me ed è essenziale che io indichi visivamente. Se avessi indicato su un lato o alle mie spalle – in un certo senso, verso cose che non vedo – l’indicare in questo caso sarebbe stato per me privo di significato; non sarebbe stato indicare nel senso in cui desidero indicare. Ma questo significa che quando indico davanti a me dicendo «questo è che ciò che viene visto realmente», anche se faccio il gesto d’indicare, non indico una cosa piuttosto che un’altra. È come quando, viaggiando in macchina ed essendo di fretta, istintivamente premo contro qualcosa che si trova davanti a me, come se potessi spingere l’automobile dall’interno.
Quando ha senso dire «vedo questo», o «questo viene visto», indicando ciò che vedo, ha anche senso dire «vedo |(Ts-309,120) questo», oppure «questo viene visto», indicando qualcosa che non vedo. Quando ho fatto la mia affermazione solipsistica, ho indicato, ma ho defraudato l’indicare del suo senso connettendo inseparabilmente ciò che indica con ciò che è indicato. Ho costruito un orologio con tutte le sue rotelle ecc. e alla fine ho assicurato il quadrante alla lancetta e l’ho fatto ruotare con essa. E in questo modo l’affermazione del solipsista «solo questo viene visto realmente» ci ricorda una tautologia.
Naturalmente una delle ragioni per cui siamo tentati di fare questa pseudo-affermazione è la sua somiglianza con l’affermazione «solo io vedo questo», o «questa è la zona che vedo», in cui indico certi oggetti attorno a me invece che altri, oppure una certa direzione dello spazio fisico (non dello spazio visivo) invece che altre direzioni dello spazio fisico. E se, indicando in questo senso, dico «questo è ciò che viene visto realmente», mi si può rispondere: «questo è ciò che tu, L.W., vedi; ma non ci sono controindicazioni all’adottare una notazione in cui ciò che eravamo soliti chiamare “cose che L.W. vede” è chiamato “cose che vengono viste realmente”». Se tuttavia credo che indicando ciò che nella mia grammatica non ha vicini posso trasmettere qualcosa a me stesso (se non agli altri), compio un errore simile a quello di pensare che la frase «sono qui» ha senso per me (e, inoltre, è sempre vera) a condizioni diverse dalle condizioni molto particolari a cui tale frase ha effettivamente senso. (Per esempio, quando la mia voce e la direzione da cui parlo sono riconosciute da un’altra persona.) – Un altro caso importante in cui si può |(Ts-309,121) imparare che una parola ha significato in base all’uso particolare che se ne fa. Siamo come persone che pensano che pezzi di legno dalla forma più o meno simile a pezzi degli scacchi o della dama, posti sopra una scacchiera, facciano un gioco, anche se nulla è stato detto su come essi debbano venire usati.
Dire «mi si sta avvicinando» ha senso, anche quando, dal punto di vista fisico, niente si sta avvicinando al mio corpo; allo stesso modo ha senso dire «è qui» oppure «mi ha raggiunto» quando nulla ha raggiunto il mio corpo. E d’altra parte «io sono qui» ha senso se la mia voce è riconosciuta e sentita provenire da un luogo particolare dello «spazio comune». Nella frase «è qui» il «qui» era un qui nello spazio visivo. È, grossomodo, l’occhio geometrico. La frase «io sono qui», per avere senso, deve attrarre l’attenzione su un luogo nello spazio comune. (E ci sono vari modi in cui tale frase potrebbe venire usata.) Il filosofo che pensa che abbia senso dire a se stesso «sono qui» prende l’espressione verbale dalla frase in cui «qui» è un luogo nello spazio comune e pensa a «qui» come al qui dello spazio visivo. In realtà, dunque, afferma qualcosa come «qui è qui».
Tuttavia, potrei cercare di esprimere il mio solipsismo in una maniera diversa: immagino che io e altri disegniamo immagini o scriviamo descrizioni di ciò che ognuno di noi vede. Queste descrizioni sono poste davanti a me. Indico quella che ho realizzato io e dico: «Solo questo è (o è stato) visto realmente». Ossia, sono tentato di dire: «Solo questa descrizione ha dietro di sé la realtà |(Ts-309,122) (la realtà visiva)». Le altre le potrei chiamare – «descrizioni vuote». Potrei anche esprimermi così: «Soltanto questa descrizione è stata derivata dalla realtà: solo questa è stata confrontata con la realtà». Ora, ha un significato chiaro quando diciamo che quest’immagine o descrizione è una proiezione, poniamo, di questo gruppo di oggetti – gli alberi che sto guardando – o che è stata derivata da questi oggetti. Ma dobbiamo esaminare la grammatica di una locuzione quale «questa descrizione è derivata dal mio dato sensoriale». Ciò di cui stiamo parlando è connesso con la strana tentazione di dire: «Non so mai che cosa l’altro intende davvero con “marrone”, o che cosa vede davvero quando (dicendo la verità) afferma di vedere un oggetto marrone». – A chi dice così potremmo proporre l’utilizzo di due parole diverse invece dell’unica parola «marrone»: una parola «per la sua particolare impressione», l’altra parola per il significato che anche altre persone oltre a lui possono capire. Se riflette su questa proposta, vedrà che c’è qualcosa di sbagliato nella sua concezione del significato – della funzione – della parola «marrone» e di altre parole. Egli cerca una giustificazione della sua descrizione dove non ce n’è alcuna. (Proprio come nel caso di un uomo che crede che la catena delle ragioni debba essere infinita. Pensa alla giustificazione dell’esecuzione di operazioni matematiche per mezzo di una formula generale; e alla domanda: questa formula ci costringe a farne, in questo particolare caso, proprio l’uso che ne facciamo?) Dire «derivo una descrizione dalla realtà visiva» non può significare nulla di analogo a «derivo una descrizione da ciò che vedo qui». Posso, per esempio, vedere un grafico in cui un quadrato |(Ts-309,123) colorato è correlato con la parola «marrone», e anche una chiazza dello stesso colore posta altrove; e posso dire: «Questo mi mostra che devo usare “marrone” per la descrizione di questa chiazza». È così che posso derivare la parola «marrone» per l’uso della mia descrizione. Ma sarebbe privo di significato dire che derivo la parola «marrone» dalla particolare impressione di colore che ricevo.
Chiediamoci: «Può un corpo umano sentire dolore?» Si è portati a dire: «Come può il corpo sentire dolore? Il corpo in sé è qualcosa di morto; un corpo non è cosciente!». E qui di nuovo è come se esaminassimo la natura del dolore e vedessimo che fa parte della sua natura che un oggetto materiale non possa sentirlo. Ed è come se vedessimo che ciò che sente dolore deve essere un’entità di natura diversa rispetto a quella di un oggetto materiale; che dev’essere, insomma, di natura mentale. Ma dire che l’ego è mentale è come dire che il numero 3 è di natura mentale o immateriale quando riconosciamo che il numerale «3» non è usato come segno per un oggetto fisico.
Possiamo però benissimo adottare l’espressione «questo corpo prova dolore» e allora, come al solito, gli diremo di andare dal dottore, di sdraiarsi e persino di ricordarsi che l’ultima volta che ha avuto dolore poi gli è passato nel giro di un giorno. «Ma questa forma d’espressione non sarebbe perlomeno indiretta?» – È usare un’espressione indiretta quando diciamo «scrivi “3” al posto di “x” in questa formula» invece di «sostituisci 3 a x»? (O invece la prima di queste due espressioni |(Ts-309,124) è l’unica diretta, come pensano alcuni filosofi?) L’una espressione non è più diretta dell’altra. Il significato dell’espressione dipende interamente da come poi noi la utilizziamo. Sforziamoci di non immaginare il significato come una connessione occulta che la mente istituisce tra una parola e una cosa, né che tale connessione contenga l’intero utilizzo di una parola come si potrebbe dire che il seme contiene l’albero.
Il nucleo della nostra proposizione, secondo cui ciò che ha dolore o vede o pensa è di natura mentale, è solo che in «io ho dolori» la parola «io» non denota un corpo particolare, perché non possiamo sostituirla con la descrizione di un corpo.
- ↑ Ludwig Wittgenstein, Interactive Dynamic Presentation (IDP) of Ludwig Wittgenstein’s philosophical Nachlass, a cura dei Wittgenstein Archives at the University of Bergen sotto la direzione di Alois Pichler, Bergen 2016–.
This translation was made possible by the financial support of: